Lei compie un’analisi di una serie di opere di storici britannici, relative alla Rivoluzione Inglese, mai tradotte nel nostro paese. Ce ne offre una sinossi?
Effettivamente, quelle a cui lei fa riferimento, nella maggioranza dei casi sono opere mai tradotte nel nostro paese. In altri casi ancora, siamo di fronte a lavori di ricerca pubblicati in italiano oltre 50 anni fa e che non sono più in commercio da moltissimo tempo; per questo motivo, si tratta di testi poco conosciuti al grande pubblico. Infine, ci sono pubblicazioni relativamente recenti di cui, per ora, non esiste un’edizione italiana. Io ho lavorato sullo studio e sulla lettura integrale di decine di questi libri. Riassumere complessivamente il contenuto di queste ricerche è praticamente impossibile. Per lo studioso o per il ricercatore interessato all’argomento, rimando alla bibliografia del mio libro. Nell’ambito di questa intervista, penso possa utile segnalare tre pubblicazioni, risalenti a periodi anche molto distanti tra loro: 1) “The Levellers and the English Revolution”, di H.N. Brailsford, del 1961. 2) “The Far Left in the English Revolution. 1640 to 1660”, di Brian Manning, uscito nel 1999. 3) “The English Civil War. 1640-1660”, di Blair Worden, pubblicato nel 2009 e, a mia conoscenza, non ancora tradotto in italiano. Henry Noel Brailsford, (25/12/1873-23/3/1958), è stato uno dei più importanti e autorevoli giornalisti britannici di orientamento progressista. Il suo libro sui Livellatori uscì a tre anni dalla sua morte, grazie al lavoro di “editing” svolto da un grande storico inglese: Christopher Hill. Si tratta, a mio parere, della più importante ricerca sull’argomento. Nelle oltre 700 pagine del libro si racchiude l’attività di questo importante movimento politico in tutte le sue sfaccettature: gruppo dirigente, iniziative dei militanti, pubblicistica di partito, contenuti programmatici e molto altro ancora. Rispetto a quello di Brailsford, il libro di Brian Manning, in termini quantitativi è un lavoro di dimensioni minori: la sua ricerca è inferiore alle 140 pagine. Ma, a mio parere, il suo lavoro è comunque prezioso. Brian Manning (21/5/1927-24/4/2004) era uno storico di orientamento marxista, allievo del sopraccitato Christopher Hill. Nel suo libro, il cui titolo potrebbe essere tradotto in “L’Estrema Sinistra e la Rivoluzione Inglese dal 1640 al 1660”, l’autore si concentra sulla storia dei movimenti politici e le lotte sociali più radicali di quel periodo. Basandosi anche sui lavori precedenti di altri ricercatori, lo storico britannico riporta alla memoria le prime lotte operaie di minatori e portuali nella metà del Seicento inglese. Blair Worden è un professore universitario britannico, nonché un eminente storico, specializzato nella storia inglese del periodo di Oliver Cromwell. Il suo pregevole libro, che ho ricordato poc’anzi, tra le altre cose è un testo fondamentale per la dettagliata ricostruzione delle vicende di guerra.
La sua ricerca è basata sul metodo comparativo. Quali sono i termini che raffronta e quali sono le ragioni che l’hanno indotta a donare ai lettori un duplice piano di lettura?
Nel mio libro, parto dal presupposto teorico che la Rivoluzione Inglese abbia anticipato fenomeni e processi sociali manifestatisi più ampiamente, e più compiutamente, in vicende storiche successive. Questo, pur rifuggendo da teorie deterministiche o basate sulla ciclicità della storia, mi ha portato ad operare una serie di comparazioni tra la Rivoluzione Inglese e altri processi rivoluzionari del  Settecento, dell’Ottocento e del Novecento. D’altra parte, come in tutti i miei libri, cerco di fornire al lettore un duplice piano di lettura: da un lato un lavoro di ricostruzione dei fatti che permetta, anche a chi non è addentro alla materia, di avere un inquadramento storico facilmente comprensibile; dall’altro, una serie di approfondimenti, di suggestioni e di chiavi di letture utili a chi ha già una serie di competenze sull’argomento.
Settecento, dell’Ottocento e del Novecento. D’altra parte, come in tutti i miei libri, cerco di fornire al lettore un duplice piano di lettura: da un lato un lavoro di ricostruzione dei fatti che permetta, anche a chi non è addentro alla materia, di avere un inquadramento storico facilmente comprensibile; dall’altro, una serie di approfondimenti, di suggestioni e di chiavi di letture utili a chi ha già una serie di competenze sull’argomento.
Un picchetto di minatori del Derbyshire nel 1649, le lotte dei portuali di Newcastle nel 1654 o, ancora, le petizioni organizzate da migliaia di donne di Londra, militanti dei Levellers (Livellatori): eventi dimenticati ma forieri di profondo interesse. Si tratta di eventi esemplificativi di modernità nella maniera in cui si sono svolti?
Come forse si può intuire dalla mia risposta precedente, il mio lavoro di ricerca parte da un’idea piuttosto semplice. La Rivoluzione Inglese, in qualità di primo processo rivoluzionario dell’età moderna, e del nascente sistema capitalista, ha in qualche modo prefigurato scenari sviluppatisi più profondamente in epoche successive. Da questo punto di vista, gli esempi di combattività operaia e di attivismo femminile che lei richiama alla mente, confermano, a mio parere, la validità dell’ipotesi da cui sono partito. Nel libro si possono trovare innumerevoli esempi che vanno in questo senso, sia in termini di Macrostoria e grandi eventi collettivi, sia in termini di comportamenti individuali.
Qual è stata l’eredità lasciata dalla Rivoluzione Inglese? C’è un prima ed un dopo?
Io tendo ad interpretare l’eredità della Rivoluzione Inglese prendendo in esame un ampio periodo che va dal 1640 al 1689. Periodo che comprende quindi la fase delle guerre civili, la Restaurazione e la cosiddetta “Rivoluzione Gloriosa” (la seconda rivoluzione sviluppatasi tra il 1688 e il 1689). Per questo, a mio parere, sarebbe più giusto parlare di singole eredità delle due rivoluzioni, tenendole separate, nella misura del possibile, l’una dall’altra. Entrambe le rivoluzioni, pertanto, presentano tratti di straordinaria modernità e attualità. Ma, a mio parere, la prima rivoluzione (tra il 1642 e il 1658 circa) offre spunti di maggiore interesse per le sue tendenze libertarie, egualitarie, solidaristiche e alternative (perlomeno in alcune sue correnti di pensiero). Anche se, da un punto di vista ideale, la “Glorious Revolution” ha il merito di avere sancito il principio della tolleranza religiosa. È stato detto che il Toleration Act (1689) rispondeva alle esigenze di una società che puntava al business e voleva liberarsi delle vecchie diatribe. Ma credo che si tratti, piuttosto, di un riflesso -sul piano legislativo- di un bisogno profondo: la volontà di vivere in pace dopo circa 150 anni di lotte religiose, roghi, torture, persecuzioni e mutilazioni.
In generale, comunque, direi che la “Glorious Revolution” ha prodotto cambiamenti profondi -economici e istituzionali- che possono essere considerati fondamentali per il funzionamento di una moderna società capitalista e che, in parte, stabiliscono un modello ancora vigente. Mi riferisco, soprattutto, alla dialettica politica che si articola tramite lo schieramento di due o più fronti parlamentari contrapposti, e alla conseguente prassi di funzionare per maggioranze di governo. Ma mi riferisco anche alla gestione finanziaria dello stato e al suo funzionamento tramite la stesura e l’approvazione di bilanci preventivi. E, ancora, a provvedimenti legislativi tesi ad incrementare il commercio estero. Ma, personalmente, sono i tratti utopistico-libertari della prima rivoluzione quelli a cui io guardo con maggiore interesse.
Lei ha conferito alla sua ricerca un taglio divulgativo. Quali difficoltà ravvede nell’avvicinare coloro che non sono specialisti di materia allo studio della Storia?
Questa sua ultima domanda mi offre lo spunto per una precisazione. Io, pur essendo un grande appassionato di storia, non sono uno storico di formazione. I miei studi universitari sono di tipo letterario, con una specializzazione in comunicazione interculturale e corsi post-laurea in linguistica. Proprio in ragione di quanto le ho appena detto, agli inizi della mia carriera di studente, prima di stabilire a quale facoltà iscrivermi, ero stato a lungo indeciso se orientarmi verso gli studi di storia, da me coltivati per molti anni come autodidatta, o verso gli studi di lingue e letterature straniere. Alla fine fu decisivo il fatto che la Facoltà di Lingue dell’Università di Genova proponesse un corso di “Scienze dell’Informazione e della Comunicazione Sociale e Interculturale”. Si trattava di un orientamento di studi dal taglio fortemente interdisciplinare, con un ventaglio molto ampio di insegnamenti delle varie scienze sociali e discipline scientifiche (sociologia, psicologia, storia sociale dell’arte, semiotica, linguistica, ecc.). La specializzazione in queste scienze, e in queste discipline, mi ha dato pertanto la possibilità di misurarmi con numerosi studi sociali che, pur partendo da approcci diversi, hanno comunque un denominatore comune.
Ma la passione per la storia era, ed è, comunque rimasta. L’idea di compiere una ricerca in campo storico aveva quindi risposto alla necessità di ricomporre l’ideale frattura consumatasi all’inizio della mia carriera universitaria, e cioè al momento di scegliere un corso di studi di letteratura anziché uno di storia.
Ma la scelta dell’argomento ed il taglio del lavoro della mia tesi (che, con studi nei 20 anni successivi, è divenuto il libro di cui stiamo parlando in questo momento) erano dipesi in modo specifico da due letture: “Le Cause della Rivoluzione Inglese”, di Lawrence Stone e “The Making of the English Working Class”, di Edward P. Thompson. Nel primo libro lo studioso -pur criticando i risultati fino ad allora ottenuti- non escludeva la possibilità che attingendo dalle scienze sociali si potessero ottenere interessanti e innovative acquisizioni in campo storico: “Con tutti i loro difetti, gli scienziati sociali possono fornire un correttivo al rimestare tra i fatti, di gusto tanto antiquario, in cui gli storici cadono con tanta facilità; possono far osservare problemi d’importanza generale, lontani dalla sterile irrilevanza di tanta ricerca storica; possono porre nuove domande e proporre nuovi modi di considerare quelle vecchie; possono fornire nuove categorie e di conseguenza nuove idee”.
Inutile dire che rimasi immediatamente affascinato dalle prospettive aperte da un simile invito. Si trattava di cimentarsi in una sfida da affrontare con la modestia e la cautela che ogni ricercatore deve avere (e che, in primo luogo, passano per uno studio attento, incrociato, e approfondito delle fonti), ma anche con la positiva ambizione di mettere in campo le competenze acquisite in anni di studio nell’ambito delle scienze sociali. Ecco, le ho fatto questa lunga precisazione perché credo che si possano avvicinare nuovi lettori alla Storia proponendo, nuove idee, nuove categorie e nuove chiavi di lettura.
Massimo Prati si è laureato all’Università di Genova in Comunicazione Interculturale. Ha proseguito gli studi in Linguistica all’Università di Ginevra, nell’ambito del DEA, e in English Literature al St Claire’s College-Oxford. È formatore a Supercomm-Ginevra e insegnante nel College Aiglon. È autore di un racconto della raccolta Sotto il segno del Grifone (2004); de I racconti del Grifo (2017) e de Gli svizzeri, pionieri del football italiano (2019).
Giuseppina Capone


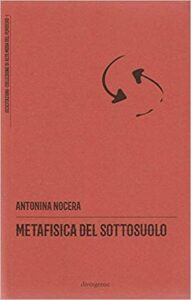 umane, il delitto, con il libero arbitrio e la coscienza: il sottosuolo dostoevskiano è propriamente il luogo dove il male, in tutte le sue forme plurime, si materializza e incarna nei personaggi: allo stesso tempo il percorso di Rogas (nel Contesto) e il suo dialogare con i vari personaggi del romanzo da Cres a Riches, sembrano essere una sorta di ‘parodia’ del sottosuolo dostoevskiano e delle sue tappe: il male come libero arbitrio rappresentato da Cres, la svolta nichilista rappresentata da Riches e la ribellione interiore di Nocio .
umane, il delitto, con il libero arbitrio e la coscienza: il sottosuolo dostoevskiano è propriamente il luogo dove il male, in tutte le sue forme plurime, si materializza e incarna nei personaggi: allo stesso tempo il percorso di Rogas (nel Contesto) e il suo dialogare con i vari personaggi del romanzo da Cres a Riches, sembrano essere una sorta di ‘parodia’ del sottosuolo dostoevskiano e delle sue tappe: il male come libero arbitrio rappresentato da Cres, la svolta nichilista rappresentata da Riches e la ribellione interiore di Nocio .
 Settecento, dell’Ottocento e del Novecento. D’altra parte, come in tutti i miei libri, cerco di fornire al lettore un duplice piano di lettura: da un lato un lavoro di ricostruzione dei fatti che permetta, anche a chi non è addentro alla materia, di avere un inquadramento storico facilmente comprensibile; dall’altro, una serie di approfondimenti, di suggestioni e di chiavi di letture utili a chi ha già una serie di competenze sull’argomento.
Settecento, dell’Ottocento e del Novecento. D’altra parte, come in tutti i miei libri, cerco di fornire al lettore un duplice piano di lettura: da un lato un lavoro di ricostruzione dei fatti che permetta, anche a chi non è addentro alla materia, di avere un inquadramento storico facilmente comprensibile; dall’altro, una serie di approfondimenti, di suggestioni e di chiavi di letture utili a chi ha già una serie di competenze sull’argomento.
 Le questioni linguistiche trascinano, smuovono le folle sui social e coinvolgono i media, spesso suscitando sdegni e querelle. Ne consegue che la grammatica riguarda tutti, giustappunto “cani e porci”: come assumere posizioni sensate tra strafalcioni e regole?
Le questioni linguistiche trascinano, smuovono le folle sui social e coinvolgono i media, spesso suscitando sdegni e querelle. Ne consegue che la grammatica riguarda tutti, giustappunto “cani e porci”: come assumere posizioni sensate tra strafalcioni e regole?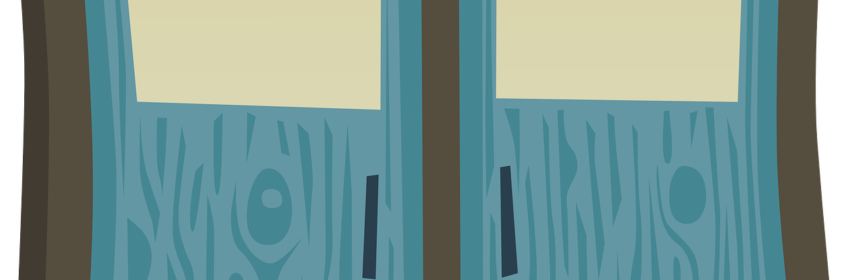
 Ne “Chiusa una porta… ti sei scordato le chiavi dentro” lei compone una sorta di canzoniere fatto d’aforismi, battute comiche, freddure, giochi di parole; ci spiega com’è riuscito a condensare in modo rapido e fulmineo argomenti ricchi di chiaroscuri quali “Amore e sessualità”, “Arte, cultura, scienza”, passando per “Lavoro, economia e finanza”, “Salute e medicina”?
Ne “Chiusa una porta… ti sei scordato le chiavi dentro” lei compone una sorta di canzoniere fatto d’aforismi, battute comiche, freddure, giochi di parole; ci spiega com’è riuscito a condensare in modo rapido e fulmineo argomenti ricchi di chiaroscuri quali “Amore e sessualità”, “Arte, cultura, scienza”, passando per “Lavoro, economia e finanza”, “Salute e medicina”?

