“S.O.S. Filosofia. Le risposte dei filosofi ai ragazzi per affrontare le emergenze della vita” ne parliamo con l’Autrice Simonetta Tassinari.
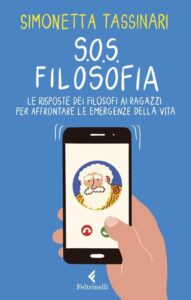 In che modo utilizza il pensiero di Platone ed Erich Fromm per offrire consigli su relazioni amorose complesse agli adolescenti?
In che modo utilizza il pensiero di Platone ed Erich Fromm per offrire consigli su relazioni amorose complesse agli adolescenti?
Platone ed Erich Fromm, tra gli altri, offrono spunti preziosi per riflettere sulle relazioni amorose, soprattutto nel caso degli adolescenti che stanno attraversando il delicato processo di scoperta di sé e degli altri. Platone, nel Simposio, ci presenta un’idea dell’amore come un itinerario di scoperta e conoscenza che evolve dall’amore per il corpo fino alla contemplazione delle idee più elevate e pure. Il suo mito della biga alata illustra perfettamente come l’amore possa unire anima e corpo e rappresenti una forza che conduce l’individuo verso la perfezione; insieme, l’amore è presentato come un cammino che, per essere compiuto, richiede crescita, comprensione e un equilibrio tra le diverse dimensioni dell’essere umano. Erich Fromm, da parte sua, ci ricorda che l’amore è un’arte che dev’essere coltivata con impegno e saggezza. Non basta la passione iniziale, occorre imparare ad amare nel tempo, affrontando le difficoltà, costruendo un legame che vada oltre l’apparenza superficiale, imparando a conoscere l’altro e soprattutto a conoscere se stessi, perché solo chi si conosce sa amare davvero. Entrambi i filosofi, dunque, suggeriscono che un amore sano non sia affatto un’utopia, bensì un obiettivo che si costruisce, passo dopo passo, con intelligenza, passione… e pazienza.
Quali insegnamenti degli Stoici e di Thomas Hobbes vengono proposti per affrontare situazioni di bullismo scolastico, e come si integrano queste prospettive filosofiche nel contesto moderno?
Hobbes, coerentemente con la sua visione della natura umana e di quanto espresso nel Leviatano, suggerirebbe di affidarsi all’autorità per risolvere il problema del bullismo, in quanto solo un potere superiore può garantire ordine e sicurezza. Gli Stoici, invece, come Seneca ed Epitteto, insegnano a non lasciarsi toccare interiormente dagli insulti e dalle ingiustizie, perché ciò che conta non è l’evento in sé, bensì il giudizio che noi diamo su di esso. Nel contesto moderno, questi due approcci si integrano: da un lato è fondamentale che le istituzioni scolastiche e gli adulti intervengano per proteggere i ragazzi, dall’altro è utile fornire agli adolescenti strumenti filosofici e psicologici per rafforzare la loro resilienza interiore.
In che modo Kierkegaard viene utilizzato per persuadere i giovani a valorizzare l’interiorità rispetto all’esteriorità, e quali argomentazioni filosofiche supportano questa posizione?
Kierkegaard, con la distinzione tra vita estetica ed etica, sospinge a riflettere su come la ricerca dell’apparenza e della popolarità possa condurre a una vita superficiale e insoddisfacente. La sua idea dell’“autenticità” come impegno esistenziale mostra agli adolescenti che concentrarsi sull’interiorità, invece di inseguire l’approvazione altrui, porta a una vita più esaminata, profonda, e anche più felice. Inoltre, il concetto dell’“ora della mezzanotte”, quella in cui la maschera cade e ci si trova ad affrontare il vuoto, dovrebbe farci comprendere che la corsa verso la perfezione non ha scopo né fine, e che piuttosto quella che va curata in ogni modo è la personalità. L’identità non si costruisce con l’omologazione, ma con scelte consapevoli.
Come viene presentata la riflessione kantiana sul “diritto di mentire” nel contesto delle decisioni adolescenziali riguardanti la verità e la menzogna?
Kant sostiene che mentire sia sempre moralmente sbagliato, anche in situazioni estreme, perché mina la fiducia alla base della società. Nel contesto adolescenziale, questa posizione viene analizzata attraverso dilemmi quotidiani: è giusto mentire per proteggere un amico? O per evitare una punizione? Le “mezze verità” sono in realtà delle “mezze bugie” , e questo dovrebbe essere il metro di giudizio basilare. Tuttavia Benjamin Constant, sul quale mi soffermo nel libro anche per stemperare il rigorismo kantiano, ci ricorda che, se dicessimo sempre e solo la pura verità, le relazioni umane sarebbero impossibili! Dunque sì al rigorismo come meta e modello, tenendo pur presente che la realtà è ben più complicata e ricca di sfumature di una regola assoluta.
In che modo il libro affronta il tema dell’ossessione per l’immagine personale, e quali filosofi vengono citati per discutere l’importanza dell’autenticità rispetto all’apparenza?
L’ossessione per l’immagine viene analizzata attraverso pensatori come David Hume, il quale è piuttosto bonario su questo “vezzo” umano, e poi Kierkegaard, che con la sua nozione di autenticità, offre una prospettiva utile per aiutare i ragazzi a liberarsi dall’ansia di essere accettati dagli altri e a concentrarsi su ciò che sono veramente, passando per l’immancabile Kant, con la sua definizione di bellezza. Anche Nietzsche è chiamato in causa con i suoi suggerimenti sul “conferire” stile al proprio carattere.
Quali emergenze della vita quotidiana degli adolescenti vengono analizzate nel libro, e come la filosofia offre strumenti per affrontarle?
Il libro affronta problematiche come la felicità, il successo, il bullismo, l’ansia per il futuro, la solitudine, la paura del giudizio, i cambiamenti in famiglia, il rapporto con la natura, i troppi impegni e il non riuscire a gestirli, e così via: per la scelta dei temi mi sono basata sia sull’osservazione dei miei alunni, che sul dialogo intessuto con loro, ma anche con i bisogni che emergono da incontri come i “Caffè filosofici”, in genere molto partecipati. In primo luogo, la filosofia, alle persone di ogni età, giovanissimi compresi, insegna a riflettere criticamente sulle proprie emozioni, azioni e decisioni, sviluppando una consapevolezza che consente di prendere distanza dai conflitti interiori e dalle pressioni esterne. Con la filosofia, gli adolescenti imparano a porsi domande fondamentali sulla propria identità, sul significato delle relazioni, sulla libertà individuale e sul proprio ruolo nella società. La filosofia, infine, promuove il valore del dialogo e della ricerca del senso, invitando gli adolescenti a indagare le proprie convinzioni e a metterle in discussione e, nel contempo, a riconoscere che la ricerca di risposte non finirà mai.
In che modo la filosofia viene presentata come una “miniera di spunti” per ridisegnare i problemi quotidiani, e quali metodologie filosofiche vengono suggerite per applicare il ragionamento alle emergenze della vita?
Il libro mostra che la filosofia, più che fornire risposte pronte, insegna a porre le domande giuste. La filosofia è una “miniera di spunti” perché fornisce strumenti di pensiero che permettono di vedere i problemi quotidiani sotto nuove prospettive. Piuttosto che fornire soluzioni immediate e preconfezionate, la filosofia insegna a porre domande, ad analizzare le situazioni con spirito critico e a sviluppare un atteggiamento riflessivo che aiuta a riorganizzare il modo in cui percepiamo le difficoltà. Le metodologie filosofiche suggerite per affrontare le emergenze della vita comprendono ad esempio: il dubbio e il pensiero critico, che aiutano a non accettare le situazioni in modo passivo, ma a esaminarle in profondità per capirle meglio; il dialogo e l’argomentazione; la ricerca di principi generali, che aiutano a individuare le connessioni tra eventi apparentemente caotici, offrendo una visione più chiara delle situazioni; l’autoconsapevolezza e la riflessione etica, che permettono di comprendere i propri valori e di prendere decisioni meditate anche in momenti di crisi.
Come viene interpretata la citazione di Cicerone “La filosofia ci aiuta nei casi più gravi e sa intervenire nelle più lievi difficoltà” nel contesto del libro?
La citazione viene utilizzata per mostrare che la filosofia non è solo un sapere astratto, ma uno strumento concreto che aiuta a gestire sia grandi crisi esistenziali sia piccoli problemi quotidiani. In questo senso, la filosofia è una “cassetta degli attrezzi” sempre utile.
In che modo il libro incoraggia i lettori a diventare “amici dei filosofi” per sentirsi più attrezzati interiormente ad affrontare cambiamenti improvvisi, come quelli sperimentati durante la pandemia?
Il libro incoraggia i lettori a diventare “amici dei filosofi” nel senso di avvicinarsi alle loro idee con curiosità, scoprendo che molte delle loro domande e risposte sono ancora attuali e possono aiutare a interpretare la complessità della vita moderna. Durante la pandemia, molti hanno sperimentato ansia, isolamento e un senso di precarietà. La filosofia aiuta a dare significato a questi momenti, insegnando che il cambiamento è una costante dell’esistenza e che affrontarlo coscientemente può renderci più forti. Attraverso il dialogo con il pensiero filosofico, i lettori imparano a sviluppare un atteggiamento più riflessivo e critico, evitando di farsi travolgere dalle paure o dall’ansia del futuro, che, come scrive Epicuro, “non è del tutto nostro, ma neanche del tutto non nostro”, sicché è possibile governarne quantomeno il pensiero. In sintesi, il libro suggerisce che essere “amici dei filosofi” non significa solo studiarli, ma lasciarsi ispirare da loro per affrontare i momenti di crisi con maggiore lucidità e determinazione.
Quali sono le principali emergenze adolescenziali trattate nel libro, e quali filosofi vengono chiamati in causa per offrire soluzioni puntuali e concrete?
Le emergenze analizzate includono l’ansia da prestazione, il senso di inadeguatezza, il bullismo, la difficoltà nelle relazioni, la paura di non riuscire a essere felici, il fatto di non piacersi, di credersi dei “falliti”, di non riuscire ad accettare i cambiamenti, in famiglia e nella vita. Per ognuna di queste, il libro propone un dialogo con i filosofi. Un esempio tra i tanti: nel capitolo relativo ai segreti sono chiamati in causa Bentham e John Stuart Mill, in quello sui cambiamenti Lao- tzu. Il ventaglio da me utilizzato è molto variegato: in realtà ho “chiamato a raccolta” i filosofi di tutti i tempi!
Giuseppina Capone
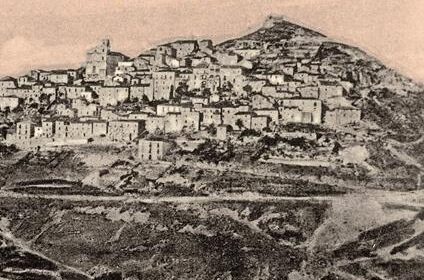
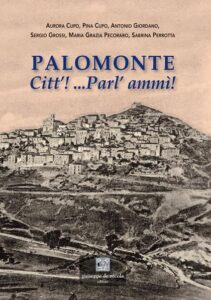 Una preziosa testimonianza da trasmettere alle giovani generazioni perché possano conoscere le loro origini e meglio comprendere vita e sviluppo socio-economico della realtà in cui vivono.
Una preziosa testimonianza da trasmettere alle giovani generazioni perché possano conoscere le loro origini e meglio comprendere vita e sviluppo socio-economico della realtà in cui vivono.

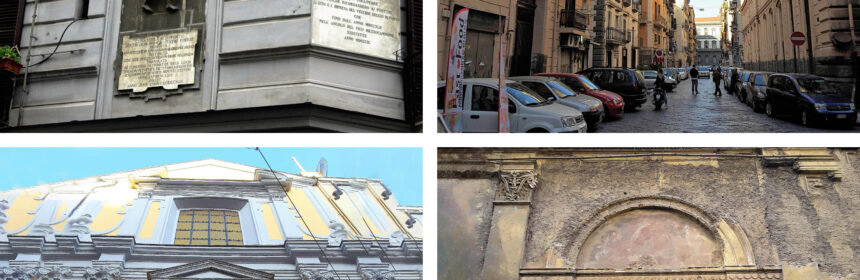

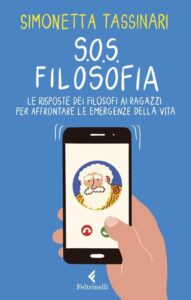 In che modo utilizza il pensiero di Platone ed Erich Fromm per offrire consigli su relazioni amorose complesse agli adolescenti?
In che modo utilizza il pensiero di Platone ed Erich Fromm per offrire consigli su relazioni amorose complesse agli adolescenti?
 La narrazione al femminile, a suo avviso, è stata per lungo tempo appannaggio maschile…
La narrazione al femminile, a suo avviso, è stata per lungo tempo appannaggio maschile…
