Non tutto il male. Cronache della terra inabitabile cita in esergo Amore e morte di Giacomo Leopardi. Ciclo di Aspasia e sguardi stranianti, allucinati e visionari.
Qual è il fil rouge che lega i due scritti in un’inusuale contaminatio fabulae?
È un filo che parte da molto lontano. Il titolo con cui Non tutto il male era nato, il suo working title per così dire, era proprio quella terra inabitabile che è confluita nel sottotitolo e che veniva da Amore e morte. E fa tutto parte di un percorso a più tappe, che comunicano fra loro. Mentre scrivevo il romanzo lavoravo anche a un saggio, insieme a Claudio Kulesko, che s’intitola Blackened – Frontiere del pessimismo nel XXI secolo e che è uscito anch’esso nel 2021, per Aguaplano. Per certi versi li vedo come testi gemelli, due lati di una stessa domanda. Il pessimismo è certamente il responsabile del linguaggio allucinato e visionario che lei nota, e che secondo me è proprio il linguaggio del dubbio, della sofferenza; ma del pessimismo non mi attrae l’aspetto alienante e caustico di un certo nichilismo, che in assenza di valori vorrebbe svuotare i significati, quanto appunto la visione dolente ma intensa di Leopardi, un’indagine piena e responsabile verso le ragioni del male. Amore e morte per me significa questo: sono i punti cardinali del nostro fato, le uniche due cose, in fondo, di cui vale la pena parlare – e di cui forse finiamo sempre per scrivere.
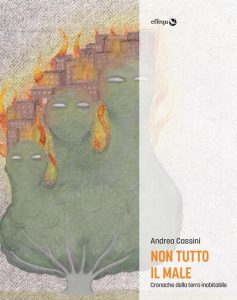 Leggere le sue pagine produce un effetto straniante tale per cui pare di essere uno spettatore della vicenda. Linguaggio e descrizioni deviano, soventemente, dal canone del romanzo di fantascienza e da aspirazioni di divulgazione scientifica. In che misura, invece, il suo romanzo recupera il sense of wonder della fantascienza classica?
Leggere le sue pagine produce un effetto straniante tale per cui pare di essere uno spettatore della vicenda. Linguaggio e descrizioni deviano, soventemente, dal canone del romanzo di fantascienza e da aspirazioni di divulgazione scientifica. In che misura, invece, il suo romanzo recupera il sense of wonder della fantascienza classica?Sono certamente un amante della fantascienza classica, ma ho avuto la fortuna (o almeno, io la reputo tale) di crescere, come lettore, senza porre particolare attenzione ai canoni. Mi sono sempre trovato in maggiore sintonia con un’idea di fantastico ampia e inclusiva, aperta alle contaminazioni, a tutto ciò che è strano e bizzarro. Mi pare che dialoghi molto bene con il presente, e del resto ho sempre pensato agli autori “fantastici” come a “realisti di una realtà diversa”, come diceva Ursula LeGuin. Il sense of wonder che lei nota in Non tutto il male risulta probabilmente da una confluenza che, nelle mie abitudini di fruitore, è la più naturale possibile fra fonti apparentemente anche molto diverse fra loro, dai poemi medievali ai videogiochi, passando per romanzi fantasy e manga giapponesi.
“Chi è stato immaginato ha questo privilegio rispetto a chi è stato partorito, che può tornare a casa, nel territorio informe dell’increato, del mai esistito.” Il suo sguardo ha implicazioni morali?
Credo che ogni nostro sguardo o gesto ne abbia. Questo non significa che un romanzo debba essere una professione di fede o un’affermazione univoca. Mi pare che i protagonisti della storia siano anzi estremamente dubbiosi, confusi, e che l’intera vicenda sia un annaspare intorno a questo dubbio. Ma la radice di tale dubbio, certo, è basilare, e la domanda, il viaggio che compiamo insieme a essa, mi pare spesso più importante della risposta – specialmente in casi dove la risposta è per sua natura inconoscibile, perché in effetti anch’io penso spesso, con Albert Camus, che il suicidio sia l’unico problema filosofico davvero degno di riflessione, e questo è incarnato dal Cartografo alla ricerca del suicidio perfetto.
Quello che mi preme sottolineare, però, e che risuona anche con le precedenti riflessioni sul fantastico, è che una buona storia (parlo in senso generale perché non sono io a dover giudicare se Non tutto il male lo sia, ovviamente) non deve esclusivamente reggersi su simboli o allegorie, su significati nascosti. Vera o immaginata che sia, la storia parla con la propria voce e dialoga con chi la legge – senza per questo essere meno “morale”. Mi piace pensare ai concetti di “credenza secondaria” e “applicabilità” di J. R. R. Tolkien, in questo senso.
Zero, il Cartografo, la “ragazza in bianco” che diventa la “ragazza in nero”. Lei strotola un freakshow davvero virtuosistico: a quale personaggio è più legato?
Non è facile rispondere in modo netto perché gli elementi di questa triade sono strettamente legati fra loro, si compenetrano, sotto molti aspetti. Alcuni lettori li hanno interpretati come tre facce della medesima persona, ed è una lettura che trovo affascinante e del tutto legittima. Mi sbilancerei forse sul Cartografo, perché come suggerisce il nome è il vero “architetto” di Tula, la città dov’è ambientato il libro, è il primo nucleo a cui ho pensato e da cui sono nati gli altri personaggi. In questo senso agisce quasi da ambasciatore dell’autore all’interno della storia, è quello che mi ha aperto una finestra per poter guardare da dentro questo mondo fumoso, e districare gli eventi.
La sua formazione è classica. Ebbene, è così arduo convivere con la Natura in assenza di un Mito che ci accompagni nelle scelte?
Temo di sì. Ho pensato più volte a quello che accade a Tula come a un gigantesco rito funebre collettivo, un funerale in assenza di cadaveri, persone che hanno visto crollare la metafisica e cercano di costruirsi un mito con le proprie mani, perché in assenza di miti non riescono a interpretare la realtà. Da qui le fratture, la depressione, i fantasmi. È un bisogno di spiritualità, ma anche semplicemente di immaginazione, che trovo molto attuale. Quello che mi preme sottolineare, e che spero emerga anche dal libro, è che la questione della convivenza con la natura è asimmetrica. Sembrerà tautologico, ma per la natura è tutto naturale, anche gli incendi, le devastazioni, tutto ciò che accade in risposta ai nostri artifici. Ho recentemente visto il film The Green Knight, che nel linguaggio profondamente immerso nel mito del poema originale riflette in modo secondo me brillante proprio su questo tema: il verde è il colore della terra, della morte che ci digerisce e ci restituisce in vita, dei rampicanti che prima o poi avvolgeranno persino il castello più alto, di un’ascia che prima o poi taglierà il collo di ogni re. E se la fine del mondo è inevitabile, citando il titolo di un bel libro, io penso che “un’altra fine del mondo è possibile”, così come esistono altri miti per raccontarla e per convivere con la natura.
Andrea Cassini di formazione filologo medievale, è giornalista, traduttore e consulente editoriale. Scrive di sport per FiBa, «L’ultimo uomo» e altre testate. Scrive articoli per «L’Indiscreto» e ha pubblicato racconti su riviste letterarie e nelle antologie Prisma – Vol. 1 (Moscabianca, 2019) e Déjà vu – altre storie, altro presente (Alessandro Polidoro, 2020). Ha partecipato come autore a Tina. Storie della grande estinzione (Aguaplano, 2020).
Giuseppina Capone

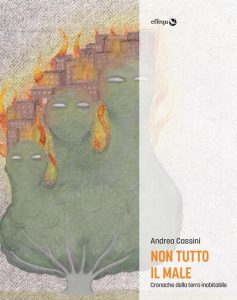 Leggere le sue pagine produce un effetto straniante tale per cui pare di essere uno spettatore della vicenda. Linguaggio e descrizioni deviano, soventemente, dal canone del romanzo di fantascienza e da aspirazioni di divulgazione scientifica. In che misura, invece, il suo romanzo recupera il sense of wonder della fantascienza classica?
Leggere le sue pagine produce un effetto straniante tale per cui pare di essere uno spettatore della vicenda. Linguaggio e descrizioni deviano, soventemente, dal canone del romanzo di fantascienza e da aspirazioni di divulgazione scientifica. In che misura, invece, il suo romanzo recupera il sense of wonder della fantascienza classica?
