Hannah Arendt. Imprevisto ed eccezione. Lo stupore della storia: quali snodi, in particolare, del pensiero arendtiano si propone di esaminare la sua monografia scientifica?
L’intento del mio lavoro è cogliere, con l’ausilio di Hannah Arendt, le sconcertanti questioni politiche del nostro tempo, innanzi alle quali servono strumenti ermeneutici al fine di comprendere un presente sempre più in krisis. I temi della riflessione arendtiana, che mi propongo di sottolineare sono sia di natura politica e storica, sia filosofica e morale. Penetrare nel suo pensiero è valso a intendere la filosofia non come speculazione teorica, ma come la possibilità di scoprire i criteri, o almeno le modalità, con cui il giudizio si fa strumento d’azione consapevole. La sua ricerca filosofica è sollecitata da fatti e avvenimenti che offrono al lettore una prospettiva teorica di rilevante interesse filosofico, politico e storico. Dall’intreccio tra pensiero ed esperienza nasce in lei la consapevolezza che solo giudicando il reale sia possibile cambiare le sorti della storia e iniziare qualcosa di nuovo insieme agli altri. Nel dettaglio, il giudizio è la categoria con la quale comprendere gli eventi passati e scegliere come agire consapevolmente nelle circostanze in cui possano prevale dubbi ed incertezze etiche e morali. Nuovi e sempre uguali pericoli investono le democrazie occidentali. Pensiamo ai nascenti populismi, al riaccendersi della paura nei riguardi dello straniero, ai nuovi fondamentalismi religiosi e ai fenomeni terroristici. La crisi della rappresentanza mostra l’esigenza di ripensare la politica, quale spazio di apparenza e di manifestazione della parola e del discorso. In un tempo in cui, i mezzi di comunicazione multimediale si sono trasformati da strumenti a luoghi, sostituendosi prima all’ agorà e poi alle sedi di partito, diventa cogente riattivare forme di cittadinanza attiva che riavvicinino la pluralità al bene comune. Quindi, l’ultimo snodo del pensiero arendtiano su cui mi soffermo è il significato autentico del politico, nel momento in cui la studiosa prova ad immaginare una rinascita della sfera pubblica nel segno di una libertà sospinta dall’azione e dall’esercizio del giudizio politico. Diventa, in tal senso, interessante seguire la sua impresa di decontrazione della storia e dei rapporti tra la filosofia e la politica, così come si sono sviluppati sin dall’età classica. Per far emergere le esperienze autentiche del politico, Arendt analizza la condizione umana, caratterizzata da distinzioni esistenziali quali il lavoro, l’opera e l’azione. Riguardo a quest’ultima, la filosofa mette in luce lo slancio innovativo dell’azione, piuttosto che gli atti che ne risultano, proprio perché agire equivale a dare inizio a qualcosa di nuovo. L’azione politica, che si differenzia nettamente dall’opera e dal lavoro, corrisponde alla condizione della pluralità, del porsi in relazione, del comunicare con gli altri. Solo da questa forma di dialeghestaie e dalla condivisione di parole e gesti l’uomo può dar senso al suo abitare il mondo.
L’umanità al cospetto delle rovine della storia; Con il totalitarismo. La deflagrazione di storia e politica; Un “nuovo inizio” per la politica e per la filosofia; Giudicare: responsabilità storico-politica ed etica.
Ciascun capitolo si presenta come possibile oggetto di studio autonomo; ciononostante, è ravvisabile un filo rosso che consenta ai non addetti ai lavori di cogliere l’interpretazione del pensiero di Hannah Arendt?
Le sue opere, dai trattati filosofici e politici, fino ai saggi su questioni morali, esprimono il desiderio di comprendere le vicende che hanno sconvolto il Novecento. I criteri, la tradizione e gli orizzonti di senso – che avevano orientato l’agire umano per millenni – sono risultati insufficienti innanzi alla comprensione delle guerre mondiali, allo sterminio degli ebrei, all’esplosione della bomba atomica, alla guerra fredda, e al propagarsi della tecnica.
Le riflessioni sul pensare, sul volere e sul giudicare proposte nell’ultima opera, rimasta incompiuta, La vita della mente, sono il compimento delle sue analisi politiche ed interpretative su Le Origini del totalitarismo, del 1951.
La questione del totalitarismo conferisce alla sua opera, apparentemente disorganica, una grande coerenza. Innanzi al fenomeno totalitario, la pensatrice vuol comprenderlo, cogliendone il senso.
Di fronte ai crimini di massa totalitari, non sono più validi né le consuete categorie storico-politiche né quelle etico-filosofiche. Questo è il cuore della prima parte del mio lavoro. Infatti, i primi capitoli mettono in luce come la ricostruzione storica e la scrittura di un evento, quale il totalitarismo, sollevino dei problemi peculiari concernenti la riflessione generale sulla storiografia, per quanto attiene agli strumenti e ai modi della spiegazione e dell’interpretazione dei fatti. Da storica, ne Le origini del totalitarismo, Arendt utilizza, con grande disinvoltura e maestria, molti materiali: dal documento storico, alla cronaca politica, dalle opere letterarie, alla testimonianza autobiografica di vite emblematiche, mettendo fine all’idea di processuali universalizzante della storia, e alla configurazione teleologica dell’accadere storico. Tra ricostruzione storica e interpretazione filosofica si pone una circolarità. Il fatto accaduto sollecita la riflessione e questa costituisce la base da cui comprendere gli eventi stessi. Al binomio causa-effetto, sostituisce la diede elementi-cristallizzazione, dando conto storicamente delle condizioni stabilizzate in forme immutabili, entro un contesto in cui l’evento ha avuto origine. Con la metafora chimica della cristallizzazione, la filosofa indica un criterio di selezione e di ordinamento dei fatti stoici volto a ravvisare i punti di fusione di elementi eterogenei che, in un determinato momento si sono cristallizzati in un’unica esperienza. In questo modo, l’antisemitismo e l’imperialismo sono elementi e componenti, non cause del fenomeno. Trovandosi di fronte ad un evento dirompente, innanzi al quale è forte la tentazione di considerarlo fuori dall’umano, sorge, in Arendt, la domanda su come sia possibile conoscere la storia nei suoi momenti bui. La risposta ad un tale quesito risiede nell’idea secondo la quale il passato, sopratutto quello doloroso, può essere conosciuto solo raccontando ciò che è accaduto. Per raccontare gli eventi, la comprensione è condizione necessaria. Il comprendere, come risulta nell’ultima opera La vita della mente, ha una stretta affinità con il pensare, perché non cerca la verità, ma il significato delle vicende. Il momento successivo alla comprensione è la narrazione, in cui si mette ordine nella sequenza caotica degli eventi. Allo storico, e al narratore, non solo spetta il lavoro di riscoperta degli eventi accaduti, ma anche il compito di giudicare quegli stessi fatti. Il giudizio non è una sentenza di condanna o di assoluzione dei fatti, ma è la particolare prospettiva con cui vengono interpretati gli eventi nel momento in cui, con la narrazione, si restituisce un racconto delle vicende.
L’esito conclusivo della riflessione di Hannah Arendt obbedisce all’urgenza di una riappacificazione con il mondo e con la storia.
Quali tendenze nel Novecento hanno tentato di smantellare la varietà umana, hanno provato a rendere accessoria l’azione politica ed hanno cercato di vanificare la realtà?
I nodi storici presi in considerazione sono il fallimento degli stati nazionali e della loro promessa di coniugare cittadinanza e universalità dei diritti umani; la massificazione della società, che trasforma gli appartenenti alle classi in atomi impotenti e isolati; l’illimitato desiderio espansionistico dell’imperialismo, che oltre a concorrere alla formazione di una mentalità dominatrice insegna all’Europa i metodi illegali e arbitrari messi a punto nelle colonie e che conducono al razzismo; l’antisemitismo che porta con sé il fardello di credenze legate al sangue e al suolo; l’elaborazione d’ideologie che pretendono di procedere in accordo con le eterne leggi della Natura e della Storia.
Arendt scorge nell’antisemitismo un problema politico, rintracciando l’antecedente storico della condizione umana dell’isolamento, al quale sono stati costretti gli ebrei, nel tramonto degli stati nazionali, allorché, privi di una identità politica, sono stati il bersaglio privilegiato di ogni teoria razziale e la loro ricchezza senza potere diventava causa di antisemitismo.
Sul piano delle considerazioni politiche del totalitarismo, la filosofa lo definisce una forma nuova di governo, distinta da tutte quelle fino ad allora conosciute. Per avvalorare questa sua concezione illustra i tratti inediti di questo regime politico, individuandoli nel terrore e nell’ideologia. Nei campi di concentramento e di sterminio – concepiti come il luogo dove l’idea stessi di dominio totale si manifesta in tutta la sua micidiale potenzialità distruttiva – Arendt vede il male farsi radicale, tra l’altro per aver privato ogni internato della spontaneità che contraddistingue l’esistenza umana. Nella storia ci sono stati altri sistemi di potere arbitrario, come la dittatura, la tirannide, il dispotismo, ma nessuno di essi ha perseguito, oltre alla distruzione della capacità politica dell’uomo, l’annientamento della stessa identità umana e del suo legame con la realtà. Il totalitarismo, nel conquistare il potere, ha eliminato tutte le tradizioni sociali, politiche e giuridiche del paese, creando istituzioni nuove. Il nuovo regime politico ha portato alle sue estreme conseguenze le caratteristiche della società di massa, trasformando le classi sociali in masse d’individui intercambiabili. Inoltre, ha sostituito il sistema dei partiti con il marito unico. Non ha solo preteso la subordinazione politica delle persone, ma ha invaso la loro sfera privata. Se il totalitarismo ha annullato la libertà degli uomini, cancellando la spontaneità dell’individuo, distruggendo la possibilità per ogni persona di condividere insieme il mondo, occorre ripensare la sfera politica, come luogo in cui gli uomini possano dar vita a qualcosa di nuovo agendo insieme. Il periodo tra il primo dopoguerra e il disgelo degli anni Cinquanta in Unione Sovietica è stato un momento di rottura imprescindibile nella storia dell’umanità, poiché gli uomini sono stati privati della possibilità di riunirsi per parlare e agire politicamente. Dopo la seconda guerra mondiale e l’olocausto, dopo l’avvento di armi in grado di distruggere la razza umana, Arendt si chiede se ci siano ancora possibilità per gli uomini d’esercitare la politica, quale forma d’azione e di libertà. Solo in uno spazio garantito e curato da diritti, gli uomini possono intervenire nel mondo orlando e agendo liberamente nella loro diversità. Arendt difende diritti e libertà per tutti, indipendentemente dall’appartenenza a uno Stato o a una nazione.
Lei scrive che il valore profondo della filosofia di Arendt va reperito “nella valorizzazione assoluta della libertà umana, libertà di dare inizio all’inatteso e al nuovo, libertà di scegliere e, se liberi, di giudicare”.
E’ il thaumazein la zattera a cui aggrapparsi?
Bello il paragone con la zattera. Del resto siamo proprio, in mare aperto, privi di ogni ancoraggio con la tradizione a cui aggrapparci. La vita è composta di imprevisti e di eccezioni. La storia è ricca di stupore e di fatti imprevisti. Ecco la scelta semantica alla base del sottotitolo del mio lavoro
Le circostanze ci obbligano a scegliere e a prendere decisioni. Ogni scelta chiama in causa libertà ed azione, pensiero e giudizio. Quindi politica ed etica. Arendt stabilisce un legame tra natalità e agire, perché entrambe sono a fondamento della libertà. L’imprevedibilità, della libertà e dell’azione, produce effetti potenzialmente illimitati. Gli uomini sono in grado di dare inizio a qualcosa di nuovo, sin dalla nascita. A tal proposito, Arendt invoca l’autorità di Agostino e ricorda l’espressione del filosofo cristiano: “Perché ci fosse un’inizio l’uomo è stato creato”. In questa espressione si manifesta l’idea della libertà come capacità di cominciare, essendo l’essere umano a sua volta un “inizio”. La nascita connatura ciascuno a generare novità nel mondo. Per Arendt siamo condannati a essere liberi in ragione dell’esser nati. L’agire appartiene alla libertà, intesa come spontaneità, cioè come facoltà di iniziare un corso non prevedibile partendo da se stessi. La libertà, per quanto diritto di nascita, non è mai definitivamente stabile, ma può essere minacciata dall’isolamento, dalla violenza, dalla tirannia, dal conformismo, e dalla società di massa. La libertà non è da intendersi come un dono, ma è da cogliere come una caratteristica vulnerabile dell’uomo, che può andare perduta. Quindi, occorre difenderla e salvaguardarla. Da qui sorge il continuo appello a pensare la pratica della libertà in termini di diritti collettivi e di impegno comune.
Arendt è conosciuta dal grande pubblico per l’espressione “la banalità del male”.
Dove sta la radice del “male”, Dottoressa Catanoso?
Male banale. Sintagma difficile che le è costato tante critiche. Ma andiamo direttamente alla risposta. Aver visto negli occhi, a Gerusalemme, in gabbia, Eichmann, ha ridimensionato la famosa espressione kantiana sul “male radicale”. Il processo a Gerusalemme è stato il momento durante il quale coglie cosa comporti la scissione tra pensiero ed azione. Il non pensare ha come conseguenza l’incapacità a giudicare. Quindi a scegliere. Obbedire, senza porsi domande diventa il segnale di un male che dall’ambito morale, diventa etico e politico. A caratterizzare Eichmann non è cattiveria, o stupidità, ma assenza di pensiero. Arendt, invece di dipingerlo come un demonio, restituisce il ritratto di un uomo qualunque. Tutti cercano un demone, intravedono mostruosità, Arendt scorge solo un uomo incapace d’attivare il giudizio, e la facoltà del pensare per porre domande a se stesso. E come lui ce n’erano tanti, nessuno perverso né sadico. Il male nella sua cruda banalità si mostra ogni volta in cui persone terribilmente normali divengono irresponsabili delle proprie scelte e delle proprie azioni. Il male va liberato da ogni sostanzialità oggettiva e ricondotto ad una responsabilità individuale, svincolandolo, così da ogni natura metafisica o demoniaca. Per giudicare bisogna farlo decidendo volta per volta. Entro una cornice di crimini autorizzati, in cui la distinzione tra il bene e il male può esser compromessa, e la decisione libera ed autonoma può essere stordita da una collettività che agisce come se fosse una sola persona, i pochi che conservano una capacità di discernimento morale la esercitano in solitudine. Ecco perché si è sempre responsabili. Si è personalmente responsabili, anche dell’irresponsabilità che accompagna ogni azione. La responsabilità dei propri atti è sempre individuale, nessuno può schermarsi dietro l’avallo di un sistema o di un’organizzazione. Questi, alla maniera di Socrate, del maestro Jaspers, mostrano con la loro vita, con il loro lavoro come sia possibile discernere, giudicare, esprimendosi con coerente equilibrio sui temi pubblici.
Il cancro del male, emblematicamente rappresentato da Eichmann, può riproporsi ogni volta in cui si cede al non pensare al non volere ed al non giudicare. Dal processo contro Eichmann ciò che si rileva è la questione della responsabilità e della colpa di quanti, pur non essendo criminali comuni, hanno svolto una funzione all’interno del regime; ma anche di quanti sono rimasti in silenzio tollerando. L’incapacità a pensare e a giudicare, prima di ogni scelta e di ogni azione, mostra una vera e propria frattura con il mondo all’interno del quale viviamo; ciò, però, non ci emancipa dal dover rispondere dell’azione compiuta.
Rosaria Catanoso è docente di filosofia e storia nei Licei e dottore di ricerca in Metodologie della filosofia.
Giuseppina Capone

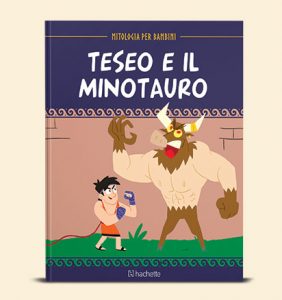 La collana di libri illustrati proposta in edicola da Hachette si compone di 70 uscite con cadenza settimanale e con la mitologia “apre le porte di un mondo di fantasia e di avventure”.
La collana di libri illustrati proposta in edicola da Hachette si compone di 70 uscite con cadenza settimanale e con la mitologia “apre le porte di un mondo di fantasia e di avventure”.
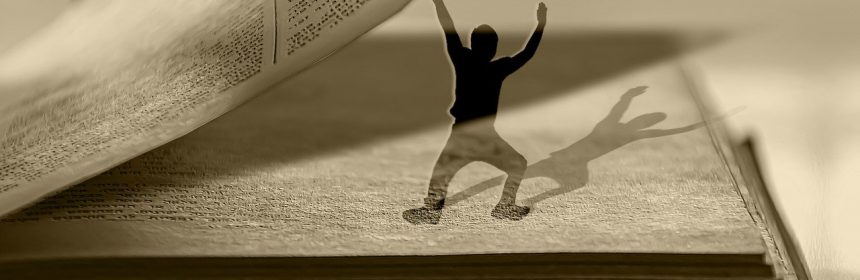
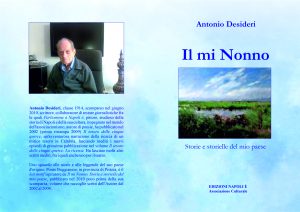 Il volume è stato ripubblicato dall’Associazione Culturale “Napoli è” nel 2021 per ricordare la scomparsa dello scrittore e collaboratore di varie testate giornalistiche e della stessa Associazione, raccoglie gli scritti dell’Autore dal 2002 al 20024.
Il volume è stato ripubblicato dall’Associazione Culturale “Napoli è” nel 2021 per ricordare la scomparsa dello scrittore e collaboratore di varie testate giornalistiche e della stessa Associazione, raccoglie gli scritti dell’Autore dal 2002 al 20024.







