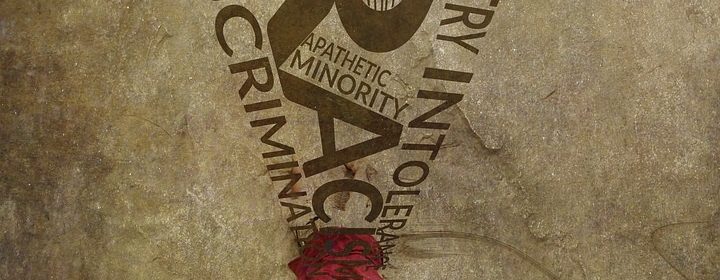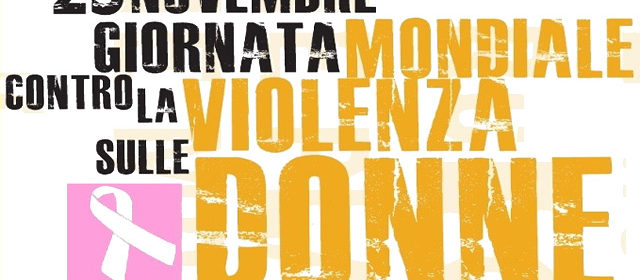Qual è il contesto storico in cui è ambientato il libro “Magistrate finalmente”?
Tra i temi affrontati dall’Assemblea Costituente vi fu il divieto per le donne di entrare in magistratura, stabilito da una legge del 1919. L’articolo 7 di quella legge impediva loro di ricoprire incarichi pubblici come quello di prefetto, direttore generale, ufficiale giudiziario, magistrato appunto, oltre a precludere le cariche elettive e molto altro. Le 21 donne elette all’Assemblea si batterono con determinazione per eliminare queste discriminazioni, ma incontrarono forti resistenze e non riuscirono a raggiungere il loro obiettivo. Solo dopo anni, con una nuova legge – la n. 66 del 9 febbraio 1963 – le italiane ottennero finalmente il diritto di accedere alla magistratura.
Chi sono le protagoniste del libro e qual è il loro ruolo nel contesto della magistratura italiana?
Le protagoniste del libro Magistrate finalmente. Le prime giudici d’Italia sono le pioniere che vinsero il primo concorso aperto anche alle donne dopo l’approvazione della legge del 1963. Racconto come si arrivò a quella legge e, nella seconda parte, le sfide affrontate dalle prime magistrate italiane, donne che non solo dovettero dimostrare le proprie capacità professionali in un contesto tradizionalmente dominato dagli uomini, ma anche rompere barriere sociali e culturali. Attraverso le loro esperienze, Magistrate finalmente mette in luce le difficoltà e le battaglie che le otto protagoniste hanno vissuto per affermare la loro presenza in un ambito cruciale della società italiana. Il libro si sofferma sugli anni ‘60, ‘70, ‘80 sino al sorpasso delle donne sugli uomini in magistratura, avvenuto per la prima volta nel 1987, quando su 300 idonei nel concorso, oltre 150 erano donne.
Quali difficoltà e resistenze hanno incontrato le prime donne magistrate italiane nel loro percorso professionale?
Ci sono diversi episodi che raccontano il clima di diffidenza e di non adeguata considerazione delle neo giudici. Ad esempio, alla milanese Emilia Capelli accadde, nel 1977, di essere chiamata una sera per un’emergenza presso il carcere minorile “Beccaria”, dove era scoppiata una rivolta. Al suo arrivo venne scambiata per un’assistente sociale, un equivoco che rifletteva i pregiudizi sull’identità e sui ruoli attribuiti alle donne. Graziana Calcagno (ligure, costruì il suo intero percorso a Torino), quando ormai era già approdata in Corte d’Appello agli inizi degli anni 80, incontrò l’ostilità di un collega che si rifiutava persino di sedere con lei – in quanto donna – in camera di consiglio (alla fine quest’uomo andò in pensione anticipatamente). Giulia De Marco, originaria di Cosenza ma anche lei attiva prima a Milano e poi a Torino, ricorda come il tradizionale “tocco” (il copricapo formale dei giudici) fosse pensato solo per gli uomini, al punto da caderle continuamente sul viso: un dettaglio simbolico che la dice lunga. Nel tempo, dando prova della loro preparazione e serietà, le otto pioniere hanno conquistato il rispetto dei colleghi e degli avvocati: parlava la qualità del loro lavoro, nel silenzio e lontano dai riflettori.
Quali sono alcuni esempi di casi giudiziari significativi trattati dalle prime donne magistrate italiane?
Le prime magistrate hanno accompagnato l’evoluzione della società che a partire dalla fine degli anni ‘60 cominciò a cambiare pelle con l’approvazione di leggi come quella sul divorzio, sul diritto di famiglia, sull’interruzione della gravidanza.
Tra i vari provvedimenti messi in atto dalle giudici, c’è ad esempio quello deciso da Capelli sul delicato caso di una coppia di Testimoni di Geova che rifiutava una trasfusione di sangue per la propria figlia affetta da una malattia emolitica. Capelli, dopo la segnalazione del medico, nominò immediatamente una curatrice speciale per consentire la trasfusione, agendo nell’interesse della minore contro la volontà dei genitori e così salvando la vita della piccola. Maria Gabriella Luccioli, classe 1940, di Terni, prima donna approdata alla Corte di Cassazione nel 1988, presiedette il collegio dell’Alta Corte che si pronunciò sul caso di Eluana Englaro, autorizzando la sospensione delle cure forzate. Una decisione coraggiosa, che suscitò feroci polemiche e segnò un prima e un dopo.
In che modo l’ingresso delle donne nella magistratura ha influenzato il sistema giudiziario italiano?
Certamente l’arrivo delle donne ha introdotto nuove sensibilità e approcci interpretativi nella giurisprudenza, importanti soprattutto nel diritto di famiglia, nella tutela dei minori e nei diritti civili. La presenza femminile ha permesso una visione più completa e attenta su temi quali la violenza domestica, sulle questioni di genere, ambiti sui quali pesava lo sguardo esclusivamente maschile.
Negli anni anche le donne hanno cominciato a ricoprire incarichi di vertice, ma è proprio nei ruoli apicali che permane ancora una netta distanza tra uomini e donne nel sistema giudiziario italiano. La nomina della prima donna a Prima presidente della Corte di Cassazione, Margherita Cassano, risale solo al marzo 2023: sono dovuti passare 60 anni dalla legge che ha cancellato il divieto di partecipare al concorso.
L’ingresso delle donne ha anche contribuito ad una maggiore attenzione verso l’equilibrio tra vita privata e professionale, influenzando il sistema a livello organizzativo. Ad esempio, negli anni, la magistratura ha iniziato a prendere in considerazione misure che tengano conto delle esigenze familiari, sia per le donne che per gli uomini, creando un ambiente di lavoro più inclusivo.
Qual è il messaggio principale che vuole trasmettere con il libro “Magistrate finalmente”?
Questo è un pezzo della nostra storia che non si conosce a sufficienza, un passo avanti importante verso la parità, e per questo credo sia necessario e istruttivo conoscerlo. Le esperienze delle prime giudici, e ancor prima delle Madri Costituenti che hanno lottato per loro, ci insegnano che bisogna coltivare la memoria, non stancarsi di battersi per i diritti, non darli mai per acquisiti, guardare sempre avanti.
Eliana Di Caro è giornalista al Sole 24 Ore dal 2000: dopo aver lavorato al mensile Ventiquattro e alla redazione Esteri del quotidiano, dal 2012 è al supplemento della Cultura “Domenica”, nel ruolo di vice caposervizio e curatrice delle sezioni di Storia ed Economia e società. È tra le autrici di Donne della Repubblica (il Mulino, 2016), Basilicata d’autore (Manni, 2017), Donne nel 68 (il Mulino, 2018), Donne al futuro (il Mulino, 2021). Ha pubblicato Andare per Matera e la Basilicata (il Mulino, 2019), Le vittoriose (Il Sole 24 Ore, 2020), Le Madri della Costituzione (Il Sole 24 Ore, 2021). Scrive dei temi legati alle donne – dei loro diritti e dell’emancipazione femminile – e della terra lucana. Appassionata di tennis, ogni tanto recensisce qualche libro sull’argomento.
Giuseppina Capone



 Si è tenuto Venerdì 8 marzo 2024, in occasione della “Giornata internazionale della Donna” e del Marzo Donna 2024, la Fondazione Casa dello Scugnizzo onlus – Centro Studi e Ricerche “Mario Borrelli”, in piazzetta San Gennaro a Materdei n. 3, Napoli, presieduta dal prof. Antonio Lanzaro ha organizzato in collaborazione con le Associazioni “Napoli è”, Voce di… Vento, NomoΣ Movimento Forense un incontro di informazione e formazione dal titolo “Una nuova stagione di diritti: Le Donne e la Società del futuro”.
Si è tenuto Venerdì 8 marzo 2024, in occasione della “Giornata internazionale della Donna” e del Marzo Donna 2024, la Fondazione Casa dello Scugnizzo onlus – Centro Studi e Ricerche “Mario Borrelli”, in piazzetta San Gennaro a Materdei n. 3, Napoli, presieduta dal prof. Antonio Lanzaro ha organizzato in collaborazione con le Associazioni “Napoli è”, Voce di… Vento, NomoΣ Movimento Forense un incontro di informazione e formazione dal titolo “Una nuova stagione di diritti: Le Donne e la Società del futuro”.