a premonizione indica una sensazione nella quale un individuo paia percepire informazioni circa eventi futuri prima ancora che essi accadano.
Qual è la differenza con il déjà-vu?
Il dejà-vu è la sensazione di sentirsi “a casa propria” in un luogo dove si è sicuri di non essere mai stati, oppure di stare per ripetere qualcosa che ci è già accaduto, pur sapendo che non è mai successo. È un fenomeno ben noto, sulla genesi del quale sono state avanzate diverse ipotesi, per lo più di tipo psicologico (e non neurologico), che finora non hanno trovato conferma.
Invece la premonizione è una previsione di ciò che succederà, da parte di un medium, o indovino, o sibilla (ma anche da parte del soggetto stesso, e in questo caso si parla più spesso di “presentimento”). Generalmente il medium (con diverse modalità) dice di entrare in contatto con una realtà superiore che non è regolata dalla Ragione o dal Caso, ma dal Fato, e cioè dal Destino, che segue una logica sua, inaccessibile alla ragione.
Per questo motivo i medium fanno in modo di estraniarsi da ogni logica razionale. Per esempio, le sibille delfica e cumana vaticinavano immerse nei vapori allucinogeni emanati dalle pozzolane di Cuma o all’interno dell’antro oracolare di Delfi. Alla base della premonizione c’è l’abbandono della razionalità e la preferenza per il pensiero analogico.
Mediante sogni e visioni si crede di intravedere porzioni di futuro.
Un lettore, oggi, se leggesse che Giuseppe Garibaldi intraprese la spedizione dei Mille per averla vista in sogno, forse riterrebbe il fatto nulla più che una curiosità aneddotica.
Per quale ragione il mondo antico reputa che la premonizione sia una cosa serissima?
Gli antichi cercavano un principio capace di spiegare come mai alcuni avevano successo in ciò che intraprendevano e altri no. Rifiutavano di accettare l’idea (oggi trionfante) che il mondo evolva in conseguenza di eventi casuali. Erano convinti che le persone di successo fossero favorite dagli dei (o addirittura fossero in qualche modo divine!).
Per quanto ci possa apparire strana, è una convinzione che, sotto diverse forme, sopravvive anche oggi: i calvinisti ritengono che il successo in affari sia il segno della benevolenza divina; in piena epoca illuminista Manzoni chiamò Napoleone “uom fatale”; lo stesso Napoleone, illuminista e materialista, pretendeva che i suoi marescialli non fossero soltanto esperti e abili, ma soprattutto fortunati. In materia di presunta benevolenza divina per questo o quel personaggio, si possono citare infiniti esempi, alcuni davvero sorprendenti.
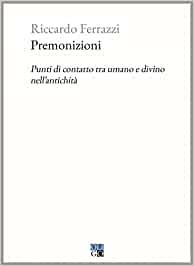 Alessandro Magno, Giulio Cesare, Mosè, Gesù ed, ancora, Costantino hanno avuto premonizioni.
Alessandro Magno, Giulio Cesare, Mosè, Gesù ed, ancora, Costantino hanno avuto premonizioni.
Qual è il tratto che li accomuna?
Non direi che in materia di premonizioni questi personaggi abbiano avuto un approccio comune.
Su Alessandro Magno non abbiamo notizie che confermino una sua fede negli oracoli (anzi: è probabile che lui stesso ci credesse a metà) ma è certo che nel corso della sua breve esistenza non mancarono presagi e fatti apparentemente inspiegabili.
Tanto Giulio Cesare quanto Costantino credevano fermamente a una realtà ultraterrena che si manifestava in diverse forme (predizioni degli aruspici, sogni, fatti strani, ecc.). La prima carica politica nella carriera di Cesare fu quella di pontefice massimo della religione pagana. Costantino, nato pagano, liberò il cristianesimo dalle catacombe in seguito a una premonizione.
Non sappiamo se Mosé ritenesse di aver avuto delle premonizioni. Certo è che sfruttò abilmente la mentalità degli ebrei antichi per far accettare l’idea che la sua azione politica era voluta da Dio.
Gesù, oltre a diverse premonizioni, ebbe dolorosissimi presagi (si pensi per esempio alla sofferenza morale e fisica che patì nell’orto di Getsemani, quando “seppe” del destino che lo aspettava e lo accettò in obbedienza al Padre).
Il convincimento che il sogno precorra la realtà è durevole e pressoché universale. Solo la cultura razionalistica tende a derubricarlo a superstizione. Un caso sempre menzionato è “sognare” i numeri al lotto, con l’annessa “manualistica” legata all’interpretazione assai nota come “Smorfia napoletana”. Quindi, l’assunto è che nel sogno siano trasmesse informazioni attraverso una cifratura simbolica che necessita di spiegazione. E’ lo stesso assunto della “Traumdeutung” freudiana?
Da un punto di vista molto generale si può anche affermare che il sogno sia un messaggio cifrato. In effetti, il sogno non fa che “mettere in scena” qualcosa che è già presente nel sognatore. Più in generale, sembra ormai accertato che il contenuto dei sogni sia una metafora di avvenimenti accaduti, o – più frequentemente – di desideri o timori di avvenimenti possibili. Quindi, anche il sogno di Costantino (En touto nikà – In hoc signo vinces) è probabilmente da considerare come la prefigurazione di un evento desiderato.
Però la Traumdeutung ha, secondo Freud, una genesi essenzialmente sessuale (cosa che non credo si possa applicare alla smorfia – salvo per il numero 77 e forse qualche altro – ma neppure ai sogni che si riferiscono a eventi di là da venire).
Personalmente ciò che mi pare davvero notevole è che il sogno descrive sempre gli avvenimenti in forma di metafora: si direbbe che nelle premonizioni il pensiero analogico si prenda la rivincita sul predominio del pensiero logico.
Caldei, etruschi, greci e romani così come Nostradamus.
Quale intimo sentire spinge l’uomo a cercare nel sogno il futuro, certo che compito arduo sia sempre “distinguer nei sogni il falso dal vero”, così come canta Guccini ne “Il vecchio e il bambino”?
Per l’affanno degli uomini a scrutare il futuro non ci può essere altra spiegazione che l’inquietudine, per non dire la paura, di vivere un’esistenza dominata dal caso. Se accettassimo l’impostazione della scienza contemporanea, secondo la quale il caso è l’unica “legge” che governa la realtà, la nostra esistenza non sarebbe altro che “timore e tremore”, come diceva Kierkegaard. Ma, come invece diceva Heidegger, l’uomo è “progettualità”. E quando si progetta qualcosa, si vorrebbe prevedere se avrà successo e a questo scopo ci si rivolge a tutte le “tecniche” conosciute.
È un dato di fatto che uomini d’affari, politici, re e regine consultano astrologhi o prendono parte a sedute spiritiche. Sono noti gli esempi di Ronald Reagan, di Breznev e di Romano Prodi (che partecipò alla seduta spiritica in cui fu indicato che Aldo Moro era prigioniero “a Gradoli”). Possiamo liquidare tutto questo come superstizione o ignoranza? Chissà. Quando si devono prendere decisioni importanti (per sé e per altri), è umano cercare di sentire tutte le campane.
Un fatto storico ben documentato avvenne nel luglio 1632, quando il cardinale Richelieu chiese all’astrologo Morin de Villefranche una previsione sul futuro del re Gustavo Adolfo di Svezia che, in quel momento, stava conducendo una campagna così vittoriosa da compromettere le iniziative diplomatiche francesi. L’astrologo previde che il re svedese non sarebbe sopravvissuto più di qualche mese. E in effetti Gustavo Adolfo morì in battaglia il 6 novembre di quello stesso anno.
Che dire? Se questo genere di previsioni si avverasse sempre, non si prenderebbe una decisione senza consultare l’astrologo. Ma è un fatto che ogni tanto le previsioni si avverano, e ci lasciano di stucco.
Riccardo Ferrazzi
Scrive romanzi e saggi; insieme a Marino Magliani traduce dallo spagnolo. In uscita presso l’editore Oligo ci sarà quest’anno anche una nuova traduzione di Le avventure di Huckleberry Finn di Mark Twain. Nel 2000, insieme a Raul Montanari, pubblica due racconti in Il tempo, probabilmente (Literalia). Altrii cinque racconti compaiono in Il magazzino delle alghe (Eumeswil, 2010), antologia curata da Marino Magliani. Cipango! (Leone Editore) romanzo che mescola realtà e ipotesi sulla scoperta dell’America è del 2013; Liguria, Spagna e altre scritture nomadi (Pellegrini), viaggi e miscellanea, scritto a quattro mani con Marino Magliani, esce nel 2015; del 2016 è il saggio sul mito Noleggio arche, caravelle e scialuppe di salvataggio (Fusta). Il romanzo N.B. Un teppista di successo (Arkadia – 2018) è una biografia romanzata del giovane Napoleone. Il Caravaggio scomparso (Golem Edizioni – 2021) è una parodia in forma di giallo. Premonizioni (Oligo – 2023) è un saggio sulle tecniche di previsione del futuro nell’antichità.
Giuseppina Capone


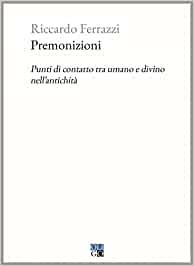 Alessandro Magno, Giulio Cesare, Mosè, Gesù ed, ancora, Costantino hanno avuto premonizioni.
Alessandro Magno, Giulio Cesare, Mosè, Gesù ed, ancora, Costantino hanno avuto premonizioni.
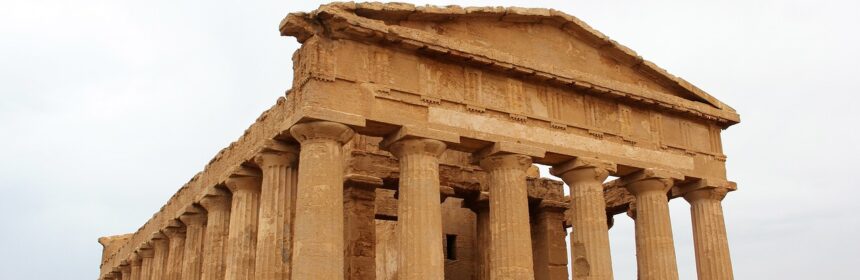


 Sarà possibile accedere e visitare: il primo piano con la Collezione Farnese, la Collezione De Ciccio, la sezione dell’Armeria Reale, le sale dell’Appartamento Reale dalle 8.30 alle 19.30 con ultimo ingresso alle 18.30; nella sala Causa, dalle 10 alle 17.30, la mostra “Gli spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale” con l’eccezionale prestito dal Museo del Prado della Madonna del pesce di Raffaello che torna a Napoli dopo 400 anni.
Sarà possibile accedere e visitare: il primo piano con la Collezione Farnese, la Collezione De Ciccio, la sezione dell’Armeria Reale, le sale dell’Appartamento Reale dalle 8.30 alle 19.30 con ultimo ingresso alle 18.30; nella sala Causa, dalle 10 alle 17.30, la mostra “Gli spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale” con l’eccezionale prestito dal Museo del Prado della Madonna del pesce di Raffaello che torna a Napoli dopo 400 anni.




