Avenida Libertador è il nome di una via di Buenos Aires.
Qual è la ragione per cui costituisce il titolo del suo romanzo?
 Avenida del Libertador è una via di Buenos Aires, emblematica quando si parla di desaparecidos, perché proprio in questa via risiede la Escuela de Mecánica de la Armada (prima Escuela Superior de Mecánica de la Armada da cui ESMA) conosciuta internazionalmente come ESMA, era la scuola per la formazione degli ufficiali della marina argentina di Buenos Aires, soprattutto per quanto riguardava la preparazione tecnica in ingegneria e navigazione. La ESMA cominciò la sua attività di centro di detenzione e tortura il giorno stesso del colpo di Stato argentino, vale a dire 24 marzo 1976. Già in quell’occasione vennero imprigionate le prime persone scomode, sequestrate dalle forze armate. Il mio romanzo è ambientato proprio all’interno di questa struttura, ho pensato quindi che non potesse esserci nome più emblematico per titolare il mio romanzo.
Avenida del Libertador è una via di Buenos Aires, emblematica quando si parla di desaparecidos, perché proprio in questa via risiede la Escuela de Mecánica de la Armada (prima Escuela Superior de Mecánica de la Armada da cui ESMA) conosciuta internazionalmente come ESMA, era la scuola per la formazione degli ufficiali della marina argentina di Buenos Aires, soprattutto per quanto riguardava la preparazione tecnica in ingegneria e navigazione. La ESMA cominciò la sua attività di centro di detenzione e tortura il giorno stesso del colpo di Stato argentino, vale a dire 24 marzo 1976. Già in quell’occasione vennero imprigionate le prime persone scomode, sequestrate dalle forze armate. Il mio romanzo è ambientato proprio all’interno di questa struttura, ho pensato quindi che non potesse esserci nome più emblematico per titolare il mio romanzo.
“Pagarono, salutarono Esteban e si diressero verso il commissariato di Buenos Aires per cercare notizie di Lucas Tizak, un nome, un cognome e un volto che loro non volevano dimenticare”
Lei affronta il tema spinoso e drammatico dei desaparecidos. Avenida Libertador ha, evidentemente, richiesto ricerche storiche accurate e meticolose. Quale metodo si è imposta di adottare per trattenere le informazioni e, poi, renderle narrativa?
Materialmente ho iniziato il libro un’estate di qualche anno fa. Poi ho sentito l’esigenza di fermarmi. Ho pensato che pur essendo il romanzo un’opera di finzione volevo essere quanto più precisa e realistica nella narrazione di ciò che i protagonisti del libro avevano vissuto nel piano immaginario e in quello reale/storico riferendomi a persone esistite fuori dalla finzione. Allora ho posato il quaderno, ricordo di averlo poggiato nella parte bassa del comodino, sopra un libro di Roberto Arlt «El juguete rabioso» e ho ripreso in mano un libro pubblicato dalla Conadep (Informe de la comisión Nacional sobre la Desaparición de personas) «Nunca más» (Mai più).
Sera dopo sera, grazie a questo prezioso documento, con prefazione di Ernesto Sábato, mi sono documentata sui centri clandestini di detenzione, ho studiato le planimetrie degli edifici, mi sono a lungo soffermata sulle procedure di sequestro. Ho inoltre letto le testimonianze dei sopravvissuti, fascicolo per fascicolo, storie dell’orrore di chi era riuscito a uscire dall’inferno. Alla fine del libro ho deciso di fare delle ricerche mirate sul web e sono riuscita a visionare alcuni processi su YouTube. Ho ascoltato più di ottanta ore di testimonianze. Solo dopo aver approfondito tutte le questioni ho ripreso il mio taccuino e quindi la stesura del romanzo. Per descrivere gli ambienti, le case, le strade ho fatto riferimento alla mia esperienza personale. Ho vissuto a Buenos Aires nel quartiere Olivos per diversi anni e ho voluto citare le zone a me più care. In calle José Maria Paz abitavo con la mia famiglia.
La «trasformazione in narrativa» è avvenuta in maniera del tutto naturale, ho abbandonato i dati e mi sono concentrata sulle sensazioni, sulle relazioni tra i protagonisti, sulla loro caratterizzazione. Si è parlato di Avenida Libertador come testimonianza letteraria, in cui l’elemento fittivo ricrea un vissuto estraneo a molti ricorrendo all’immaginazione. Ed è proprio così, nel romanzo la realtà e la finzione si fondono continuamente . Così come succede all’inizio quando racconto dell’incontro di Eva (madre di Tamar) con Enrique. Eva è un personaggio inventato, Enrique esiste davvero è uno scrittore contemporaneo spagnolo Enrique Vila-Matas, maestro indiscusso dell’autofinzione iberica. Lo scrittore ha soggiornato davvero nella mansarda di Margherite Duras, così come è vero che in diverse interviste ha dichiarato di voler fare lo scrittore dopo aver visto Mastroianni che sposa Jean Moreau nel film «La notte» di Antonioni. Ho voluto rendere omaggio a Enrique Vila-Matas perché sono convinta che sia uno dei pochi maestri viventi di quella letteratura che Borges chiamava universale.
Ho voluto altresì omaggiare Aldo Moro, ed è per questo che lo cito in sovrapposizione con il protagonista del romanzo Lucas, credo che sia importante denunciare qualsiasi tipo di estremismo che esso sia di destra o di sinistra, ed è quello che ho voluto fare citando il famoso statista italiano.
A pensarci bene quando scrivo realtà e finzione si fondono a tal punto che spesso persone in carne e ossa diventano personaggi e i personaggi a loro volta sembrano essere miei amici fisici, veri.
La sparizione forzata è un fenomeno che si è verificato anche in numerosi paesi e in differenti momenti storici, situazioni per le quali il termine desaparecidos è divenuto una “parola mantello” d’uso comune.
Ebbene, la lotta politica, l’adesione ad una causa: i nostri tempi possono ospitare, a suo avviso, siffatti propositi di cambiamento sociale?
Questi tempi sono profondamente diversi da quelli in cui è ambientato il romanzo ovvero la dittatura argentina. È vero che il termine desaparecido è ormai parola mantello, ma nonostante abbia assunto un valore universale quando pronunciato ricorda subito il «processo di riorganizzazione nazionale» voluto da Videla. Un progetto che aveva come obiettivo quello di mettere a tacere con la sparizione forzata qualsiasi individuo si opponesse al regime. Un piano programmato per annientare il nemico con delle pratiche che ricordano molto quelle adottate dal regime nazista da cui i militari argentini presero ampi spunti. L’Argentina come il Cile all’epoca erano terre di accoglienza per gli ex nazisti fuggiti dalla Germania subito dopo la caduta di Hitler. Basti pensare che Eichmann è stato arrestato dalla polizia israeliana proprio a Buenos Aires nel ’60 e l’angelo della morte Josef Mengele ha vagato per tantissimi anni tra il Brasile e l’Argentina. Il processo di riorganizzazione nazionale seguiva la stessa logica hitleriana, l’annientamento dell’individuo che veniva da subito privato del nome e della propria identità e dignità, seguiva un periodo di prigionia che si concludeva o con la liberazione o con la sparizione.
I forni crematori vennero sostituiti dai voli della morte…
Ancora oggi sono 30 mila i desaparecidos e altrettante le famiglie in attesa di un impossibile ritorno. Diceva un testimone della dittatura che la cosa più difficile è questa: Non sei morto, non sei vivo: sei desaperecido. Per cui non puoi anelare alla pace dell’anima così come non possono farlo i tuoi cari.
Se vogliamo parlare dell’oggi e fare un esempio che possa toccarci da vicino, i genitori di Giulio Regeni per alcuni giorni hanno cercato il proprio figlio, desaparecido anch’esso e non in un Paese in dittatura, ma nel Paese in cui il giovane dottorando portava avanti i propri studi. Una sparizione forzata quella di Giulio per cui tanti si sono mobilitati, fino alla scoperta del suo corpo. La madre vide nel volto malconcio del figlio «tutto il male del mondo». Giulio cadavere è tornato a casa, i desaperecidos no, continuano a vagare senza la possibilità di un ritorno.
A tenere alta l’attenzione sul tema le tantissime associazioni capitanate dalla più antica Madri di Plaza de Mayo.
Il cambiamento risiede nella capacità dell’individuo di denunciare questi soprusi, nel fare in modo che sin nessuna parte del mondo si debba assistere ancora a questo tipo di fenomeni, isolati come nel caso di Giulio, collettivi come nel caso dei desaparecidos argentini.
“Le forze vennero meno e cadde. Calci e pugni lo raggiunsero da ogni parte. Uno dei due uomini lo prese per i capelli, costringendolo a mettersi in piedi e gli spense una sigaretta sulla palpebra destra.”
Com’è riuscita a descrivere l’inferno?
Devo essere sincera, non lo so ancora. Era forte in me la volontà di scrivere un libro che potesse dare voce ai 30 mila desaparecidos e volevo che il racconto fosse quanto più vicino alla realtà che hanno vissuto. Sono stata ore in silenzio immaginando le scene prima di trasporle su carta. Le faccio un esempio: per descrivere il parto di Luz mi sono sdraiata a terra facendo finta di avere mani e piedi legati, ho chiuso gli occhi e ho fatto un viaggio nelle sensazioni della protagonista.
Le pagine che ha scritto grattano il fondo del realismo senza alcuna edulcorazione.
Quale messaggio etico, morale, politico ha inteso veicolare?
Soltanto con durezza si può descrivere quel periodo storico.
Il romanzo non intende veicolare nessun messaggio politico. L’ho scritto per un dovere etico nei confronti di me stessa. L’ho scritto per non dimenticare, per dare voce ai 30 mila desaparecidos, perché fin quando ci sarà memoria si potrà chiedere verità, giustizia e si potrà gridare con forza «Mai più.»
Cristina Amato nasce a Catania il 21 Agosto del 1980.
Figlia di un funzionario dell’ambasciata italiana, dall’età di 4 anni è in viaggio con la famiglia soggiornando, anche diversi anni, nei luoghi dove il padre viene trasferito. Sarà così che Cristina vive l’intero arco della giovinezza toccando diverse culture, dall’Australia all’Argentina fino in Svizzera, sviluppando una personalità profonda ed eclettica che la porta ad appassionarsi in modo particolare alla lettura e alla scrittura.
Nel 1995 rientra in Sicilia dove frequenta il liceo linguistico Sant’Orsola, dopo il diploma si traferisce in Svizzera dove frequenta l’università di Neuchâtel nella quale, nel 2006, consegue la Laurea in Lettere e Scienze Umane con una tesi in lingua spagnola sullo scrittore Enrique Vila-Matas dal titolo «Patologías literarias en la biblioteca infinita de Enrique Vila-Matas».
Nel 2013, dopo essere rientrata a Catania, pubblica il suo primo romanzo «Ogni tanto mi tolgo gli occhiali» (Inkwell edizioni, 2013), romanzo molto fortunato che le permette di conquistare la vetta dei best-seller di Amazon per ben 26 ore.
Nel 2014 pubblica anche la raccolta «Fogli Sparsi» (Inkwell edizioni, 2014) dall’omonima pagina Facebook.
Nel 2016 la 13lab editore ripubblica nuovamente «Ogni tanto mi tolgo gli occhiali» presentato al Teatrino delle Beffe di Palermo a marzo dello stesso anno e a Ginevra in occasione del Festival International d’Italie di Carouge.
Avenida Libertador (Divergenze, 2020) è alla sua quarta ristampa.
Attualmente lavora come Direttore Creativo presso un’agenzia pubblicitaria di Catania. Cristina è appassionata di letteratura e di cinema. Affetta da patologie letterarie, sta ancora contando i propri sogni nel cassetto ed è attualmente al lavoro sul suo terzo romanzo.
Giuseppina Capone

 Avenida del Libertador è una via di Buenos Aires, emblematica quando si parla di desaparecidos, perché proprio in questa via risiede la Escuela de Mecánica de la Armada (prima Escuela Superior de Mecánica de la Armada da cui ESMA) conosciuta internazionalmente come ESMA, era la scuola per la formazione degli ufficiali della marina argentina di Buenos Aires, soprattutto per quanto riguardava la preparazione tecnica in ingegneria e navigazione. La ESMA cominciò la sua attività di centro di detenzione e tortura il giorno stesso del colpo di Stato argentino, vale a dire 24 marzo 1976. Già in quell’occasione vennero imprigionate le prime persone scomode, sequestrate dalle forze armate. Il mio romanzo è ambientato proprio all’interno di questa struttura, ho pensato quindi che non potesse esserci nome più emblematico per titolare il mio romanzo.
Avenida del Libertador è una via di Buenos Aires, emblematica quando si parla di desaparecidos, perché proprio in questa via risiede la Escuela de Mecánica de la Armada (prima Escuela Superior de Mecánica de la Armada da cui ESMA) conosciuta internazionalmente come ESMA, era la scuola per la formazione degli ufficiali della marina argentina di Buenos Aires, soprattutto per quanto riguardava la preparazione tecnica in ingegneria e navigazione. La ESMA cominciò la sua attività di centro di detenzione e tortura il giorno stesso del colpo di Stato argentino, vale a dire 24 marzo 1976. Già in quell’occasione vennero imprigionate le prime persone scomode, sequestrate dalle forze armate. Il mio romanzo è ambientato proprio all’interno di questa struttura, ho pensato quindi che non potesse esserci nome più emblematico per titolare il mio romanzo.

 La mostra allestita per questa occasione dall’Associazione Culturale “Napoli è” e dal Museo dei Sedili di Napoli rappresenta solo un piccolo spaccato del più ampio e complesso progetto che vede, sin dal 1997, l’Associazione protagonista della riscoperta della storia, delle tradizioni e dei luoghi dei Sedili di Napoli con mostre, cortei e rievocazioni storiche, collaborazioni con istituzioni scolastiche ed Enti, studi, pubblicazioni.
La mostra allestita per questa occasione dall’Associazione Culturale “Napoli è” e dal Museo dei Sedili di Napoli rappresenta solo un piccolo spaccato del più ampio e complesso progetto che vede, sin dal 1997, l’Associazione protagonista della riscoperta della storia, delle tradizioni e dei luoghi dei Sedili di Napoli con mostre, cortei e rievocazioni storiche, collaborazioni con istituzioni scolastiche ed Enti, studi, pubblicazioni.
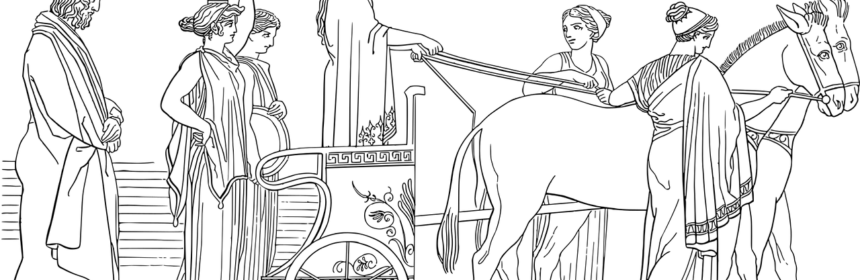
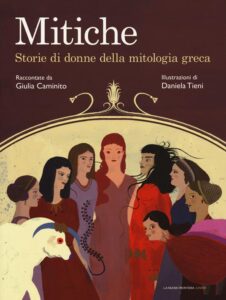 «Antigone guardò lo zio e pensò al padre, alla madre, ai fratelli che aveva perduto, alle lacrime, ai viaggi, alle armi, ai tradimenti e seppe che lei non avrebbe fatto ancora torto alla sua famiglia, ignorando il corpo di Polinice. Lei non si sarebbe arresa.» Antigone come Medea, Penelope, Arianna, Circe. Perché ha dato loro voce?
«Antigone guardò lo zio e pensò al padre, alla madre, ai fratelli che aveva perduto, alle lacrime, ai viaggi, alle armi, ai tradimenti e seppe che lei non avrebbe fatto ancora torto alla sua famiglia, ignorando il corpo di Polinice. Lei non si sarebbe arresa.» Antigone come Medea, Penelope, Arianna, Circe. Perché ha dato loro voce?



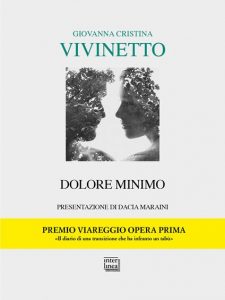 “Dolore minimo” è un diario in versi, una dolcissima raccolta in cui la poesia si fa dispositivo d’esistenza e ci pone in grado di renderci gioiosi, allegri, sofferenti, mutando i mali più intimi in astri scintillanti ed in luminosi pensieri appaganti. La poesia come volano di profondi contenuti sociali, esistenziali ed umani.
“Dolore minimo” è un diario in versi, una dolcissima raccolta in cui la poesia si fa dispositivo d’esistenza e ci pone in grado di renderci gioiosi, allegri, sofferenti, mutando i mali più intimi in astri scintillanti ed in luminosi pensieri appaganti. La poesia come volano di profondi contenuti sociali, esistenziali ed umani. 

