Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alle celebrazioni in ricordo di Enrico Berlinguer all’Università di Sassari.
“Voi mi avete ricordato delle frasi che mi sono piaciute particolarmente, di quelle dette da nostro padre. Io ne vorrei ricordare una che dà il senso giusto di come è stata la sua vita. Almeno per come l’ho pensata io. Quella che dice: – noi siamo convinti che il mondo, anche questo terribile, intricato mondo di oggi, possa essere conosciuto, interpretato, trasformato. In vista del servizio dell’uomo, del suo benessere, della sua felicità. La lotta per questo obbiettivo è una prova che può riempire degnamente una vita. – E la sua vita è stata interamente dedicata al raggiungimento di questo obbiettivo.”.
Un velo di emozione, contenuto nella consolidata esperienza professionale al pubblico confronto, accompagna il saluto finale di Bianca Berlinguer.
La giornalista romana, già direttrice della terza rete Rai, ha concluso, con alcuni intensi, intimi ricordi di famiglia, la cerimonia in ricordo del centenario della nascita del papà Enrico.
 L’iniziativa, promossa dal Senato Accademico dell’Ateneo sassarese, ha preso il via, intorno alle 11.00 del 25 maggio, con l’arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
L’iniziativa, promossa dal Senato Accademico dell’Ateneo sassarese, ha preso il via, intorno alle 11.00 del 25 maggio, con l’arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Prima dell’ingresso in Aula Magna, dopo l’esecuzione del brano “Su patrioutu sardu a sos feudatarios” ad opera del Coro dell’Università di Sassari, diretto dalla Maestra Laura Lambroni, è stata scoperta una lapide dedicata alla vita di Enrico Berlinguer. Posta nel piano superiore del loggiato, accanto a quella in memoria del Presidente Francesco Cossiga.
L’impeccabile esecuzione dell’inno di Mameli è stata realizzata dal tenore turritano Francesco Demuro.
“Enrico Berlinguer ha portato queste virtù e anche qualche difetto di noi sardi, nel grande mondo dell’impegno politico. Per capire quale sia la sua influenza, il suo carisma, la sua eredità basterebbe ricordare il giorno triste ed epico dei suoi funerali.”.
Nel saluto iniziale il Magnifico Rettore Gavino Mariotti ha tratteggiato alcuni aspetti umani del politico sassarese. Valori che il Governatore della Regione Sardegna Christian Solinas, ha ampliato in un quadro storico. Presidiato da una selezione importante di politici e intellettuali sardi che precedettero o incrociarono l’impegno e l’azione di Berlinguer.
“Lavorare insieme. Essere uniti non significa pensare tutti allo stesso modo ma saper ascoltare.
Per dare il giusto valore a ogni contributo. Il programma europeo PNRR deve essere attuato.
Per un cambiamento che tutti comprendano. In questo ambito è determinante una adeguata comunicazione della ricerca scientifica.”
L’apertura al dialogo, lo sforzo di operare azioni sociali per il bene di tutti, riconosciute nel pensiero di Berlinguer sono state recepite dalla rappresentante del Governo nazionale intervenuta da Roma.
Sintetica e diretta, la Ministra dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa.
La figura politica dello statista è stata visitata nella prolusione del professor Omar Chessa, ordinario di Diritto Costituzionale, presso il dipartimento di giurisprudenza dell’ateneo sassarese.
“L’eredità morale e politica di Enrico Berlinguer”, il titolo conferito dal docente sassarese incentrato nella cifra etica insita nel pensiero berlingueriano.
“In realtà, l’eredità è una sola e si tratta perciò di un’endiadi. E’ questa, a mio avviso, la cifra specifica del lascito berlingueriano. Non c’è un’eredità politica che non sia anche morale e viceversa.”
L’incipit del giurista è il preludio di una lettura della vita politica culturale di Berlinguer a tutto tondo.
In una visione geo politica di quell’epoca, denominata talvolta in una vulgata approssimativa della così detta “Prima Repubblica”.
L’attrattiva popolare che circonda la statura internazionale di Berlinguer, rendendolo degno del massimo rispetto da ogni differente credo politico, è espresso nella forma più lucida e fluida dal relatore.
“Non ci può essere una scissione tra agire pubblico e postura privata. Sotto questo profilo lo “stile Berlinguer” fu esemplare. Norberto Bobbio, in un articolo comparso nell’Unità del 12 giugno 1984, scrisse che la <<caratteristica fondamentale di Berlinguer>> era di <<non avere i tratti negativi che contraddistinguono tanta parte della classe politica italiana>>: la <<vanità>>, l’<<esibizionismo>>, il <<desiderio di primeggiare>>. La sua vita privata era nettamente separata da quella pubblica. La sua convinta e tenace riservatezza era una condizione imprescindibile del suo agire come politico.”.
Prima del congedo, il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo consegna alla famiglia Berlinguer, rappresentata in sala dai quattro figli, un attestato di Alta Benemerenza.
Nel saluto finale del Capo dello Stato: “da un lato l’orgoglio dell’ateneo per aver concorso a formare un protagonista della vita democratica del nostro Paese e dall’altro l’omaggio a questa figura, appunto, protagonista della vita del nostro Paese.”.
Una figura con “la tensione morale e il profondo rispetto per la Costituzione e le sue regole, due aspetti inscindibili, strettamente collegati che rappresentano un messaggio sempre attuale per la nostra Repubblica”.
Anche l’amministrazione comunale ha ricordato la ricorrenza alle 12.30, dopo la cerimonia in Università, con l’inaugurazione di un monumento ad opera dell’artista Igino Panzino.
Il video della cerimonia in ateneo è fruibile al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=cqNY-1_IUMQ&t=839s
Luigi Coppola






 L’iniziativa nata nel 1997 a cura dell’Associazione Culturale “Napoli è” è diventata un appuntamento fisso.
L’iniziativa nata nel 1997 a cura dell’Associazione Culturale “Napoli è” è diventata un appuntamento fisso.
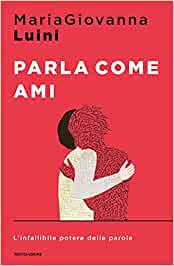 “Aderire con il cuore e la mente a una visione che oltrepassi la materialità”
“Aderire con il cuore e la mente a una visione che oltrepassi la materialità”
 L’iniziativa, promossa dal Senato Accademico dell’Ateneo sassarese, ha preso il via, intorno alle 11.00 del 25 maggio, con l’arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
L’iniziativa, promossa dal Senato Accademico dell’Ateneo sassarese, ha preso il via, intorno alle 11.00 del 25 maggio, con l’arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
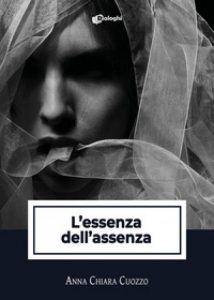 Tra le pagine del libro emerge che la memoria ha un doppio fondo: è il ricordo di ciò che è accaduto e, contemporaneamente, il ricordo di quel che non è avvenuto in quel che è accaduto.
Tra le pagine del libro emerge che la memoria ha un doppio fondo: è il ricordo di ciò che è accaduto e, contemporaneamente, il ricordo di quel che non è avvenuto in quel che è accaduto.

