Alfredo Zucchi ha fondato la rivista letteraria digitale «CrapulaClub» (2008-2019), dal 2019 è socio di Wojtek Edizioni. Ha pubblicato il romanzo La bomba voyeur (Rogas, 2018) e la raccolta di racconti La memoria dell’uguale (Polidoro, 2020). E’ autore di Una possibilità del linguaggio. Pierre Menard come metodo.
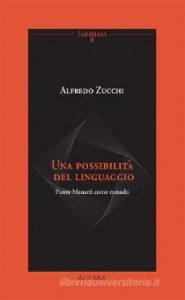 Chi è Pierre Menard e quali sono le ragioni che l’hanno indotta a farne materia di studio?
Chi è Pierre Menard e quali sono le ragioni che l’hanno indotta a farne materia di studio?
Pierre Menard è uno scrittore francese che, nel racconto di Jorge Luis Borges “Pierre Menard, autore del «Chisciotte»” (in Finzioni), si adopera in un’impresa impossibile, eroica e ridicola al tempo: scrivere, alla lettera, il Don Chisciotte di Cervantes essendo Pierre Menard. Ci riesce, in parte: secondo Borges, negli anni ’30 del XX secolo, Menard scrive alcuni capitoli della prima parte del Chisciotte. Giudichi lei il risultato:
“Il raffronto tra la pagina di Cervantes e quella di Menard è senz’altro rivelatore. Il primo, per esempio, scrisse (Don Chisciotte, parte I, capitolo IX):
«…la verità, la cui madre è la storia, emula del tempo, deposito delle azioni, testimone del passato, esempio e notizia del presente, avviso dell’avvenire.»
Scritta nel secolo XVII, scritta dall’ingenio lego Cervantes, quest’enumerazione è un mero elogio retorico della storia. Menard, per contro, scrive:
«…la verità, la cui madre è la storia, emula del tempo, deposito delle azioni, testimone del passato, esempio e notizia del presente, avviso dell’avvenire.»
La storia, madre della verità; l’idea è meravigliosa. Menard, contemporaneo di William James, non considera la storia come indagine della realtà, ma come la sua origine. […] Altrettanto vivido il contrasto degli stili. Lo stile arcaizzante di Menard resta straniero, dopo tutto, e non senza qualche affettazione. Non così quello del precursore, che maneggia con disinvoltura lo spagnolo corrente della propria epoca” (J.L. Borges, Tutte le opere. Vol. I, Milano, 1989, p. 652-3).
Quest’opera di Menard, tuttavia, è sotterranea e incompiuta – rappresenta un limite della letteratura, da un lato (un limite che sfiora il ridicolo); dall’altro rappresenta un metodo. Nel racconto in questione Borges infatti formalizza una tecnica narrativa che chiama “attribuzione erronea e anacronismo volontario”. Questa tecnica ha due aspetti: il primo consiste nel fare della letteratura già scritta la condizione principale e il materiale primario della letteratura che si sta scrivendo; il secondo invece riguarda il ribaltamento sistematico del principio di causa-effetto.
Quando Borges scrive, con leggerezza affettata, che “questa tecnica, di applicazione infinita, ci invita a scorrere l’Odissea come se fosse posteriore all’Eneide” (p. 658) sta dicendo che c’è modo, in letteratura, di costruire uno spazio narrativo in cui l’ordine del tempo si inverte, in cui le fondamenta del pensiero rappresentativo si sgretolano – sta dicendo dunque che la letteratura è in grado di aprire uno spazio di esplorazione a partire dal quale si può osservare il mondo in modo radicalmente decentrato. Questo straniamento dello sguardo ha effetti concreti: tutto è in dubbio, niente più è neutro, neanche la freccia del tempo, nemmeno la vita e la morte.
Può offrirci qualche esempio di meccanismo metanarrativo?
Resto con Borges che, nel saggio “Magie parziali del «Don Chisciotte»”, offre un esempio nitido di com’è fatto un meccanismo narrativo e di quali sono le sue implicazioni: nel testo e fuori dal testo, per chi scrive e per chi legge.
“Questa compilazione di storie fantastiche raddoppia e torna a raddoppiare fino alla vertigine la ramificazione di un racconto centrale in racconti giustapposti […] È nota la storia che dà origine alla serie: il desolato giuramento del re, che ogni sera si sposa con una vergine che fa decapitare all’alba, e l’ingegnosa trovata di Shahrazad, che lo distrae con racconti, finché sui due hanno girato mille e una notte ed ella gli mostra il figlio nato da lui. […] Nessuna ci turba quanto quella della notte DCII, magica fra tutte. In quella notte il re ode dalla bocca della regina la propria storia. Ode il principio della storia, che comprende tutte le altre, e anche – in modo mostruoso – se stessa. Intuisce chiaramente il lettore la vasta possibilità di codesta interpolazione, il curioso pericolo che nasconde? Che la regina persista e l’immobile udrà per sempre la tronca storia de Le mille e una notte, ora infinita e circolare…” (J.L. Borges, Altre inquisizioni, Milano 2005, p. 51)
Ho sottolineato in corsivo, nella citazione, il “curioso pericolo”. Cosa vuol dire e in che senso ci riguarda?
“Perché ci inquieta il fatto che le mille e una notte [siano comprese] nel libro delle Mille e una notte? […] Credo di aver trovato la causa: tali inversioni suggeriscono che se i caratteri di una finzione possono essere lettori o spettatori, noi, loro lettori e spettatori, possiamo essere fittizi” (p. 52).
Credo che in questo punto, all’incrocio tra una questione teorica (la tecnica narrativa in questione, il ribaltamento del principio di ragione) e una questione privata (il curioso pericolo: gli effetti di un simile ribaltamento sullo sguardo del soggetto: di chi scrive, di chi legge) si situi il nucleo di Una possibilità del linguaggio. Pierre Menard come metodo.
Il saggio che apre il libro opera un raffronto con Michel Foucault de La follia, l’assenza d’opera.
Quali sono i legami tra l’esperienza della follia e la letteratura fantastica per quanto attiene il linguaggio?
Nel saggio La follia, l’assenza d’opera Michel Foucault opera un parallelismo tra il linguaggio della follia (a partire dall’opera di Freud) e quello della letteratura. Per Foucault il nesso riguarda un movimento specifico del linguaggio, il modo in cui quest’ultimo implica se stesso, facendo di tale autoimplicazione la condizione necessaria della sua decifrabilità.
Nell’esperienza della follia a partire da Freud e in quella della letteratura a partire da Mallarmé, secondo Foucault, la parola si avvolge su stessa e si sdoppia. Lo sdoppiamento azione una dinamica: una “fuga incontrollabile [della parola] verso una dimora sempre senza luce” (Storia della follia nell’età classica, Milano, 2001, p. 478).
Sono partito da qui e mi sono chiesto: che cosa accade se applico questo principio dinamico a insiemi narrativi più ampi, alla letteratura che fa un uso sistematico dei meccanismi di autoimplicazione? Qui sono comparsi Borges e i procedimenti metatestuali, metanarrativi e metaletterari della letteratura fantastica– a questi si sono poi aggiunti Julio Cortázar, Danilo Kiš, Ricardo Piglia, Furio Jesi e Roberto Bolaño.
Quando ho cominciato a elaborare il saggio non avevo idea che sarebbe diventato un libro – pensavo, questo è certo, di dover provare ad approfondire il nesso, a cercare di vedere dove mi avrebbe portato. Poi ho capito che questo nesso riguardava una questione personale: il posizionamento della letteratura (cioè di chi scrive) rispetto a un conflitto specifico: la cristallizzazione dell’orizzonte del senso. Si tratta di una questione in qualche modo politica. Viktor Šklovskij ha scritto che lo scopo dell’arte è sottrarre l’oggetto dello sguardo all’automatismo della percezione. Ho cercato, con Borges (e per farla finita con Borges), di spingere quest’idea fino al suo limite estremo, fino al corpo del soggetto che tenta di sottrarre l’oggetto dello sguardo all’automatismo della percezione. Per questo il saggio si chiude con Bolaño e con i suoi poeti nazisti in America.
Ritiene che “il fantastico” sia una possibilità del linguaggio?
Sì. Questa definizione è di Alberto Chimal, scrittore messicano che ho avuto la fortuna di intervistare qualche anno fa insieme a Luca Mignola ( http://www.crapula.it/una-possibilita-del-linguaggio-intervista-a-alberto-chimal/ ) – mi pare una definizione precisa e adeguata. Il fantastico, come posizionamento dello sguardo e come attitudine letteraria, riguarda ciò che Matteo Moca (https://www.osservatoriocattedrale.com/sonar-1/2021/4/1/il-racconto-come-dispositivo-di-osservazione ) ha chiamato “messa in discussione dello statuto di realtà” attraverso un’esplorazione delle “possibilità escluse”. Riguarda dunque il tentativo di allargare – forse smagliare – l’orizzonte di ciò che, per abitudine o per convinzione, per paura o per falsa coscienza, chiamiamo realtà.
Giuseppina Capone
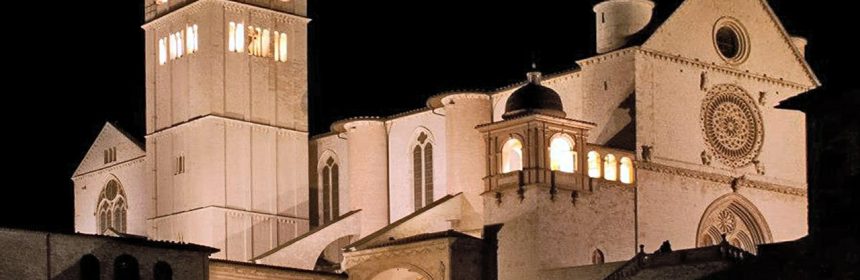


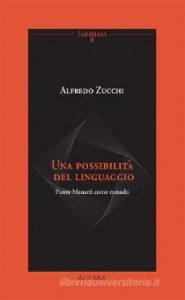 Chi è Pierre Menard e quali sono le ragioni che l’hanno indotta a farne materia di studio?
Chi è Pierre Menard e quali sono le ragioni che l’hanno indotta a farne materia di studio?

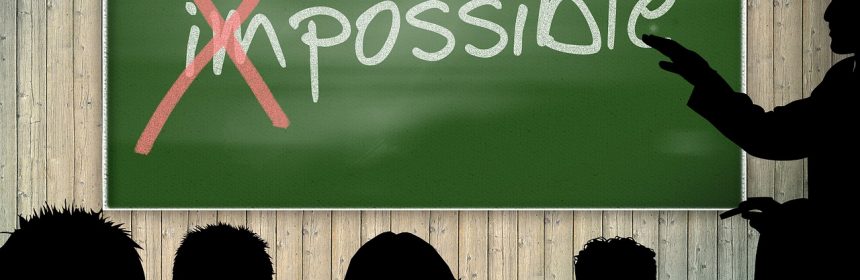

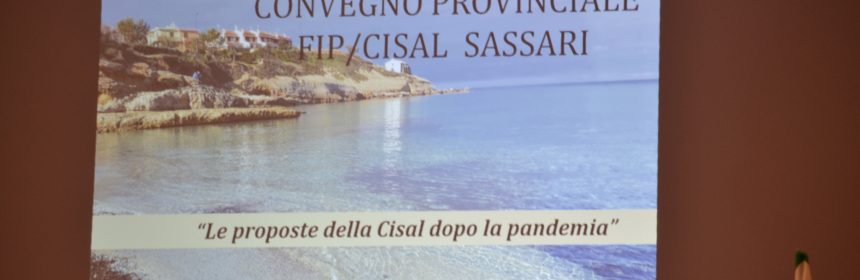
 L’incipit nel saluto istituzionale di Massimo Mulas, sindaco di Porto Torres, apre i lavori del Convegno Provinciale FIP CISAL di Sassari, realizzatosi nel pomeriggio del trenta settembre, presso l’auditorium comunale “Filippo Canu” a Porto Torres.
L’incipit nel saluto istituzionale di Massimo Mulas, sindaco di Porto Torres, apre i lavori del Convegno Provinciale FIP CISAL di Sassari, realizzatosi nel pomeriggio del trenta settembre, presso l’auditorium comunale “Filippo Canu” a Porto Torres.
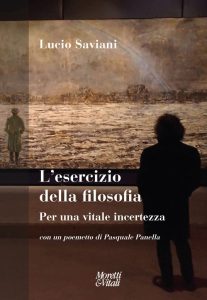 Il “limite”, attraverso i temi del confine, del gioco, del silenzio e dello stile in filosofia, è da anni al centro dei suoi lavori. Ebbene, “L’esercizio della filosofia” quale ulteriore apporto offre a “Voci di confine. Il limite e la scrittura” ed a “Ludus Mundi. Idea della filosofia”?
Il “limite”, attraverso i temi del confine, del gioco, del silenzio e dello stile in filosofia, è da anni al centro dei suoi lavori. Ebbene, “L’esercizio della filosofia” quale ulteriore apporto offre a “Voci di confine. Il limite e la scrittura” ed a “Ludus Mundi. Idea della filosofia”?

