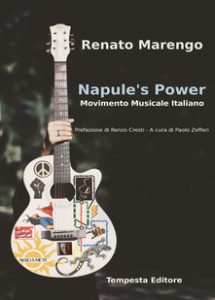 Il movimento musicale Napule’s Power, che quest’anno celebra il mezzo secolo, si dipana, appunto, attraverso decenni nonché attraverso plurimi e molteplici generi.
Il movimento musicale Napule’s Power, che quest’anno celebra il mezzo secolo, si dipana, appunto, attraverso decenni nonché attraverso plurimi e molteplici generi.
Ebbene, come nasce e come si sviluppa?
Nasce alla fine degli anni ‘70, a seguito di un periodo che aveva visto un proliferare di canzonette napoletane non più all’altezza dell’immensa musica napoletana prodotta alla fine dell’800 e durante i primi del ‘900.
Nasce per la presenza a Napoli delle basi NATO.
I giovani napoletani iniziano ad ascoltare Paul Anka, i Beatles, i Platters: c’era ovunque fermento musicale. I ragazzi anziché continuare ad ascoltare canzonette, degrado della grande tradizione napoletana, con melodia e ritmo d’alto livello, cominciano ad apprezzare lo swing. Renzo Arbore, Fred Bongusto, Peppino Di Capri, Peppino Gagliardi, Il giardino dei semplici: nascono artisti che “modernizzano” la canzone napoletana, rendendola omologa alla musica proveniente dall’America.
Il vero Napule’s Power è fatto di musica autonoma, creata, inventata.
Da chi? Ebbene, negli anni ‘60 c’era, da un lato, Renzo Arbore, jazzista, che, insieme, tra gli altri, a Roberto Murolo, applicava lo swing alla musica napoletana; dall’altro lato, c’era un gruppo formidabile, The Showmen con Franco Musella, James Senese e Franco Del Prete, i quali cantano in italiano modulando la voce alla maniera dei jazzisti neri americani.
I giovani musicisti napoletani frequentano a Napoli, ovviamente, locali situati vicino al Porto, a Bagnoli, a Posillipo, dove ascoltano musica rock, jazz…Importante è la presenza della NATO. Ogni sera, scendevano dalle portaerei americane miriadi di giovani. Invadevano i locali a caccia di alcool, “signurine” e musica. Molti portavano con sé gli strumenti: i musicisti napoletani, giovanissimi, suonavano con questi ragazzoni americani. A loro davano i nostri ritmi e le nostre melodie; noi prendevamo l’interzionalità. C’era una commistione di blues, swing, musica americana, musica napoletana. Una meravigliosa contaminazione che genera musica nuova: il Napule’s Power.
Io l’ho chiamato così: un napoletano americanizzato!
“Power” perché eravamo giovani ribelli. C’era stato il ‘68. Noi non tolleravamo il saccheggio che a Napoli si perpetrava da chi era vicino ad Achille Lauro. Non dimentichiamo “Le mani sulla città” di Franco Rosi. Non dimentichiamo Eduardo De Filippo che, dal teatro, cercava di educare alla cultura. La Nuova Compagnia di canto popolare con Roberto De Simone s’impegnava in tal senso con la musica popolare. Pino Daniele, Tullio De Piscopo, James Senese, Tony Esposito, Enzo Avitabile, che frequentavano la musica americana, si davano da fare per creare un movimento. A questo movimento diedi il nome, appunto, di Napule’s Power.
Alcuni di questi artisti, li ho prodotti io stesso perché da Napoli difficilmente sarebbero decollati. Io in quegli anni ero un giornalista italiano, non solo napoletano, lavoravo tra Napoli, Roma, Milano, venezia e mi occupavo di rock per una rivista molto importante, Ciao 2001, un po’ come l’attuale Rolling Stone. Allora, l’unica rivista ad occuparsi di jazz, rock e blues era proprio Ciao 2001. Vendeva tra le settanta e le ottantamila copie a settimana. I ragazzini facevano la fila all’edicola per accaparrarsi un numero. Io andavo a Londra per intervistare Tina Turner. Andavo a vedere i concerti dei Genesis. Con quella cultura riconoscevo nella musica nostra, napoletana, moderna, una cultura molto simile. Così ho prodotto Tony Esposito, Teresa De Sio, Nuova Compagnia di canto popolare, Eduardo ed Eugenio Bennato, Musica Nova, Concetta Barra. Li ho aiutati a farsi conoscere su queste riviste specializzate ed in RAI dove avevo programmi insieme a Carlo Massarini e Raffaele Cascone. Ho accostato i Napoli Centrale a gruppi internazionali. Inoltre, dopo averne scritto, parlato in radio e TV, ho ottenuto l’attenzione della discografia internazionale, tutta a Milano ed ostile alla musica napoletana, assimilata a Mario Merola. Ho portato il Napule’s Power al Festival internazionale di Monterey e ad Harlem. I neri del Black power ed i “negri” del Vesuvio. Sì, ci chiamavano così. Pino Daniele scriverà “Nero a metà”.
Negli anni ‘80 i ragazzi sono meno impegnati socialmente. La musica del Napule’s Power ha una battuta d’arresto, a parte Tony Esposito con Kalimba De Luna, Tullio De Piscopo con Andamento lento, Alan Sorrenti con Figli delle stelle.
Negli anni ‘90 c’è un ritorno all’impegno politico-sociale: ecco, 99 Posse ed Almamegretta. La musica napoletana è riascoltata con attenzione.
Oggi, i musicisti napoletani, soprattutto rapper, sono sostenuti da un sociologo Lello Savonardo, docente di “Teorie e Tecniche della Comunicazione” e “Comunicazione e Culture Giovanili” presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Lei cita musicisti legati alla ricerca colta e popolare, artisti folk e dal curriculum internazionale, giovani appassionati di rock’n’roll ed artisti visionari. Qual è il fil rouge sotteso a siffatta avvincente variatio generis?
No, Giusy, dammi del “tu”! E’ così che sono abituato!
Il fil rouge è la voglia di cambiare, evolvere, pur mantenendo le radici ben piantate nella tradizione. Roberto De Simone, ad esempio, cerca, con Carlo D’Angiò ed Eugenio Bennato, di recuperare i canti autentici della tradizione. Evolvere, non trasformare o violentare. Quelli citati sono grandissimi interpreti, sia strumentali che vocali, i quali hanno ascoltato e visto il rock; pertanto, nel loro spirito di ri-proposta della musica popolare c’è un legame con ciò che si sente e si fa in radio ed in televisione. La Nuova compagnia di canto popolare è portata da me a Milano ad aprire un concerto della PFM: ambedue rinnovano la tradizione. La PFM innova con gli strumenti elettrici. La Nuova compagnia di canto popolare con gli strumenti acustici. Durante quel concerto i ragazzi salgono sulle sedie e battono le mani come a scandire un rock! La fusione è la chiave!
Era il 1971 quando tu, Renato, concepisti d’adottare la definizione Napule’s Power per accorpare e scortare la vita musicale partenopea.
Erano gli anni del Black Power, il ’68 pulsava ancora.
Dunque, quale ascendente assume la politica nel panorama musicale che ha osservato?
Prescindendo da ciò che oggi significa “Destra” e “Sinistra”, nel 1970 Destra era conservatorismo; Sinistra era avanguardia, orientata al rinnovamento, alla modernizzazione. Per esempio, Eduardo De Filippo era un intellettuale di Sinistra e sosteneva Valenzi quale candidato sindaco, vicino alla cultura del rinnovamento. A Napoli, la Destra era addirittura ancora monarchica, arcaica. La Destra era rappresentata da faccendieri voraci. La Sinistra colta, universitaria auspicava il rinnovamento, l’evoluzione culturale. Si vuole, con la Sinistra,allontanare la cultura del Pulcinella, del “tutto passa”. Cito una canzone, sì divertente: “Ah, che bellu ccafè. Sulo a Napule ‘o ssanno fa” di Nino Taranto. Ebbene, è una dichiarazione di rassegnazione, di assistenzialismo. Pino Daniele idealmente risponde con “Na′ tazzulella è cafè/E mai niente cè fanno sapè/Nui cè puzzammo e famme/O sanno tutte quante/E invece e c’aiutà c′abboffano è cafè”: il caffè usato come tranquillizzante, una droga che blocca il pensiero.
La “cartolina” fotografa i napoletani rappresentati dal binomio “pizza e mandolino”, proiettandoli così lungo sentieri inclinati ed escamotage di cliché e luoghi comuni. I musicisti del Napule’s Power hanno recuperato il volgare, il folclore, il sincretico per affrancare lo spazio identitario da ingredienti nocivi quali l’asfittica trappola nel vicolo cieco delle concezioni duali: moderno – arretrato, sviluppo – sottosviluppo.
Il Napule’s Power, pur indissolubilmente legato a Napoli, ha contribuito alla deterritorializzazione di Napoli stessa?
Brava! Gli artisti che ho citato prima, tutti o quasi tutti, avevano tentato di farsi produrre un disco. A Napoli, tuttavia, erano abituati alle canzoni di Aurelio Fierro, Tullio Pane, Mario Merola, per cui li consideravano dei perditempo, degli squilibrati e non artisti. Si voleva conservare un’immagine olografica, superata, abituata alla politica del “tira a campare”, del “qualcuno ci penserà”. Non dimentichiamo che a Napoli la camorra aveva le sue radici: alla camorra faceva comodo una Napoli felice con le canzonette, una Napoli credente alle superstizioni, che affida l’anima alla Madonna piuttosto che mettersi a lavorare per cambiare la propria esistenza; una Napoli socialmente disimpegnata, inconsapevole dei propri diritti e dei propri doveri. Una Napoli internazionale, riscattata dalla “cartolina” del ladruncolo, del furbetto, è quella che spinge tutti noi, scrittori e musicisti, intellettuali tutti vogliono testimoniare il cambiamento.
Napoli come Benjamin ha ingegnosamente sintetizzato è una “città porosa”: una combinazione affascinante di coerenza-incoerenza.
Gli artisti, protagonisti della tua narrazione, vanno da Pino Daniele ad Enzo Avitabile, da Lina Sastri a Patrizia Lopez. Moltissimi sono stati prodotti proprio da te.
Ci racconti un aneddoto che rievochi, Renato, con particolare nostalgia?
Più che con nostalgia, con simpatica ironia. Io sono diventato produttore per puro caso. Quando conosco la Nuova compagnia di canto popolare, ero già ambientato a Milano, Venezia, Roma. Tornato a Napoli, mentre scrivevo della PFM, vengo rimproverato da Eugenio Bennato di non scrivere della Nuova compagnia di canto popolare! Io mi sento quasi sfidato. Vado ai loro concerti e scrivo articoli pubblicati su Ciao 2001 con lo stesso taglio con cui parlavo della PFM. Ancora, Eduardo Bennato l’ho prodotto quasi per caso: Eugenio Bennato mi chiede di dare una mano al fratello, Eduardo, appunto, che già da sette anni provava ad imporsi come cantautore. Che faccio? Frequento Eduardo, lo presento ai discografici ed Eduardo, originale, bravissimo, diventa subito un protagonista.
Renato Marengo è un conduttore radiofonico, produttore discografico, giornalista e critico musicale italiano, scrittore. Ideatore del Napule’s Power, è stato creatore e conduttore di Demo di Radio1Rai. E’ tornato di recente alla Radio con due trasmissioni diffuse su tutto il territorio nazionale: ClassicRockonAir e Suoni e parole dalla città. Dal 2012 è direttore responsabile del mensile Cinecorriere. E’ passato alla storia per essere stato l’unico giornalista ad aver intervistato Lucio Battisti (intervista che ha raccontato in due libri: l’ultimo dei quali Parole di Lucio). E’ direttore artistico di Terra Battente, del BandContest di RockContest di ClassicRock e coordinatore della Mostra C.A Bixio Musica & Cinema nel 900. E’ docente presso l’accademia di Cinema e Tv Griffith di Roma del corso di Musica da Film.
E’ stato coordinatore generale del settimanale Ciao 2001. Ha collaborato con le maggiori testate quotidiane e settimanali nazionali tra cui Sorrisi e Canzoni TV, Radiocorriere TV, Telepiù. È stato anche autore e conduttore di numerosi programmi Rai. E’ autore di “Napule’s power- Movimento Musicale Italiano” con la prefazione di Renzo Cresti, curato da Paolo Zefferi, Tempesta Editore.
Giuseppina Capone



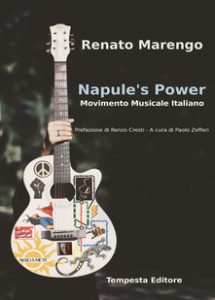 Il movimento musicale Napule’s Power, che quest’anno celebra il mezzo secolo, si dipana, appunto, attraverso decenni nonché attraverso plurimi e molteplici generi.
Il movimento musicale Napule’s Power, che quest’anno celebra il mezzo secolo, si dipana, appunto, attraverso decenni nonché attraverso plurimi e molteplici generi.
 Peppe e Arianna si vedono e fanno sesso; Luca fa il cameriere nella pizzeria dove i due ogni tanto vanno e si diverte a osservarli; tenta di sedurre Brigida; Sergio e Cristina sono i rispettivi ex di Arianna e Peppe, animati da sete di rivalsa.
Peppe e Arianna si vedono e fanno sesso; Luca fa il cameriere nella pizzeria dove i due ogni tanto vanno e si diverte a osservarli; tenta di sedurre Brigida; Sergio e Cristina sono i rispettivi ex di Arianna e Peppe, animati da sete di rivalsa.








