“Non esiste cosa più triste del voler cambiare il proprio aspetto perché convinti del fatto che, per essere belli, per essere accettati, bisogna a tutti i costi somigliare al canone di bellezza che ci mostrano. Io non posso credere che ogni donna voglia davvero essere uguale ad un’altra e che si sottoponga addirittura a una o più chirurgie plastiche per non essere quella diversa, per avere il corpo e il viso che ci impongono di avere. Rendiamoci conto, una volta per tutte, che ancora oggi non siamo liberi di scegliere come vogliamo essere, che ci annientano la personalità e ci manovrano come marionette, ed è per questo che spesso mi pongo questo quesito: chi stabilisce come debbano essere le donne e qual è il modo giusto di vedere le cose? Io credo sia giusto confrontarsi e ispirarsi a qualcuno o a qualcosa ma senza annientare sé stesse. Il fatto è che noi crediamo di essere liberi di scegliere ma è la società che decide come dobbiamo essere e senza accorgercene obbediamo. Il modo in cui lo fanno non è diretto. In modo subdolo giocano sulla nostra psiche mirando sul nostro punto debole, ovvero sull’aspetto estetico di una donna: pubblicità, social media e tanto altro, per inculcare nelle nostre menti che quelle sono le regole giuste da seguire e che se non le rispetti non sarai accettata e, automaticamente, senza neppure che possiamo accorgere, pur di esserlo, diventiamo un branco di pecore pronte ad obbedire al nostro pastore. Quindi, il messaggio che voglio mandare alle donne, è quello di riflettere e cercare di uscire da questa trappola che non ci fa vivere una vita felice ne tanto meno indipendente. Siate voi stesse, qualunque corpo voi abbiate, qualunque colore della pelle abbiate e da qualsiasi posto voi veniate”.
Quando una donna non segue tutte le regole per essere esteticamente impeccabile come vorrebbero che fosse, è facile che possa sentirsi derisa, o, addirittura, emarginata, esclusa in diversi ambiti soprattutto quelli lavorativi. Sembra quindi che disobbedire al canone di bellezza che ci viene imposto dalla società sia quasi eresia. Bisognerebbe, dunque, seguire precisamente ogni regola per essere accettati, per essere considerati: essere sempre alla moda indossando capi d’abbigliamento di tendenza, non solo, anzitutto riuscire ad avere un aspetto esteriore che sia alla pari dello stereotipo di perfezione che ci mostrano, ossia, che la vera bellezza sia quella di avere un corpo magro. E pare proprio che, non rientrare nella categoria della donna perfetta, chiuda tutte le porte, poiché una donna con un corpo da Barbie viene assunta immediatamente qualsiasi sia il settore lavorativo, per una donna oversize, invece, la probabilità che possa essere assunta è più difficile. Purtroppo chi ci rimette sono coloro che scelgono di vivere la loro vita nel modo indipendente senza sentirsi in obbligo di dover avere un corpo o un viso chirurgicamente ritoccato come chiede oggi la società. Ma secondo quale punto di vista di quale persona abbiamo deciso quale debbano essere le cose belle e quali quelle brutte? La vera bellezza è, semplicemente, quella che i nostri occhi riescono a vedere, a percepire nonostante le diverse imperfezioni che possa avere il corpo di una donna o anche di un uomo. Addirittura di un oggetto o di un animale. Ciò che conta è sentirsi a proprio agio nella propria pelle, vedersi belli allo specchio così come si sceglie liberamente di essere a seconda della propria indole, carattere e soprattutto di un personale gusto, a secondo di come si osserva la vita, perché tutto ciò che vedono i nostri occhi può diventare perfetto secondo il modo in cui decidiamo noi di osservarlo e di viverlo. In sostanza, sentirsi liberi di scegliere come voler essere è fondamentale, perché ci si sente, di conseguenza, accettati per quello che realmente si è, e soprattutto si ha la facoltà di condurre la vita che si desidera e non quella che vuole qualcun altro.
Samantha, quarantuno anni, racconta la sua storia da donna oversize.
Samantha, come vivi la relazione con il tuo corpo?
La mia relazione con il mio corpo è ottima, finalmente, dopo quasi trentaquattro anni di conflitto tra me e lui, me e la società. Oggi lo vedo come un alleato e parte di me, cerco di curarlo e tenerlo efficiente (ho 41 anni anche se non li dimostro e diversi traumi sportivi alle spalle) non lo vedo come un biglietto da visita o qualcosa da modificare, so che cambia con il tempo e lo accetto. Mi piace molto essere tonda, mi piace il mio viso e credo di essere fortunata, mi piacciono molto le donne tonde. Certo è normale anche per me ogni tanto essere giù di morale, o insoddisfatta, ma è una cosa passeggera e di certo determinata dall’influenza massiccia dei mass media e dei social (e di photoshop). Io credo che anche il corpo di una donna in carne possa essere attraente. Non si tratta, naturalmente, di incitare la donna ad avere a tutti i costi il corpo di una donna curvy, perché fino al momento in cui questo non causa problemi come l’obesità, tutto è lecito e ognuno deve sentirsi libero di stare bene nel proprio corpo senza il timore di essere preso in giro o che ogni giorno possa esserci qualcuno che ti guarda con l’aria disgustata.
Quale consiglio dai alle donne Curvy per far si che accettino il proprio corpo?
Accettare il proprio corpo non è facile, va detto, bisogna lavorare dentro di sé, studiare, mettere in discussione i mass media, la società e le esigenze del ‘business del corpo’ come lo definisco io, darsi molto tempo, riprovare, essere indulgenti con noi stesse e con gli altri corpi e persone, informarsi e non fermarsi alle facili formulette per la perdita di peso. Non solo, chiedere aiuto qualora non si dovesse avere la forza di farcela do soli. Molte donne non sanno nemmeno di essere dismorfofobiche o di soffrire di disturbi della propriocezione e alimentari. Direi loro, prima di tutto, di ricordare che il cibo è una necessità e avere fame è naturale, rinunciare al cibo non aumenterà il nostro valore, e diventare magre come ci vogliono non aumenterà al nostra autostima perché non sono questi i valori che contano nella vita quanto la persona che scegli di essere. Le direi di non dar retta a chi non sa fare altro che soffermarsi sull’aspetto esteriore perché di quelle persone non ne avrà bisogno perché non faranno parte della sua vita. Provare ad accettare il proprio corpo nonostante diverse imperfezioni vi renderà perfette perché avrete imparato a guardare la vita con semplicità e soprattutto a dare importanza alle cose che contano davvero: l’essenza di una persona. Iniziare a pensare al proprio corpo come a un alleato da amare, coccolare, preservare, mostrare, vestire bene. Non a caso il motto della mia linea è: se ti piace è già l’abito adatto a te. Io mi sentivo divina e ho iniziato a vestirmi da diva. Vi assicuro che ha funzionato. Scegliete di indossare quello che vi fa impazzire non quello che vi camuffa, cercate online: c’è di tutto per qualsiasi taglia. Vestirci come ci piace ha un grande potere, perché l’accettazione parte dalla mente per poi arrivare al cuore e al corpo. Soltanto quando ci sono in ballo problemi di salute legati all’obesità, si dovranno prendere provvedimenti. Ma fin quando si tratta di essere “rotondette” o fuori dal canone di perfezione che impone la società, fregatevene.
Sei mai stata vittima di bullismo?
Oh si, sin da piccola, ovunque, e anche da adulta. Perché ero bimba grassa e bizzarra, da ragazzina ero grassa e non vestivo con abiti firmati, un calvario che però mi ha fortificata non poco. Anche ora che ho quarantuno anni sento battute, raccolgo occhiate, ma è molto diverso, non mi tiro indietro se c’è da difendermi o difendere.
Fatevi aiutare, se sentite di essere troppo oppresse, chiedete aiuto a qualcuno di neutro e autorevole. Ricordate che spesso chi vi discrimina è un poveraccio pieno di problemi che maschera fragilità e insicurezza attaccando voi, proiettando su di voi il mostro che lui vede in sé stesso. Con questo non voglio dire che dobbiate lasciarlo fare, può farvi pena ok, ma voi dovete proteggervi e proteggere le altre vittime d ei bulli.
Hai avuto difficoltà anche a cercare lavoro?
Mentre studiavo cercai anche lavoro in un bar, in diversi ristoranti e pub. Mi sentivo dire continuamente no, fino a quando decisi di domandare il perché: “abbiamo bisogno di clientela, e per averla abbiamo bisogno di u n bel corpo femminile che serve ai tavoli”. Scappai in lacrime, anche perché avevo solo 22 anni. Ad oggi gli avrei fatto una bella risata in faccia. Penso sia una cosa molto triste questa, perché scelgono ragazze belle anche se non sono capaci di servire un caffè. Nel 2014 ho capito che potevo creare per altre donne abiti come da sempre creavo per me stessa. Sono cresciuta con nonna sarta e magliaia, ha sempre realizzato per me abiti bellissimi e da lei ho imparato a cucire. Crescendo ho capito che per la mia taglia non c’era nulla di mio gusto quindi ho iniziato presto a cucire per me. Avere un mio stile unico e gusto autonomo nel vestire è stata per me una grande rivincita contro tutte quelle persone che vestono uguali. La mia passione vera non è la moda, ma l’arte: sono laureata in scultura all’accademia di Brera e di Atene. Poco tempo fa mi chiesero se volevo sfilare come modella Curvy ma rifiutai. Non ho mai pensato di diventare modella, almeno non nel significato classico del termine, ma essere esempio (role model come direbbero in USA), quello si, vorrei essere una donna esemplare più che una modella. Mi piace usare il mio corpo come mezzo per comunicare e aiutare le altre donne, ma mi piace molto anche fare ricerca e parlare ai convegni\ conferenze. Essere modelle oggi, con tutto il carico di responsabilità nei confronti delle donne e bambine, è un compito difficile, anche per le modelle oversize e curvy, che spesso dimenticano che non basta essere belle, bisogna essere anche esemplari. Attenzione però, a percepire bene il significato messaggio che voglio mandare. Mi spiego: non è incitare le donne ad essere in sovrappeso perché si sa che l’obesità è una malattia, e non è nemmeno un messaggio per dire loro che fanno bene ad esserlo, Ma è, chiaramente e per chi lo riesce a capire, un messaggio di conforto per far capire loro che fanno bene a sentirsi a proprio agio con il proprio corpo nonostante vengano prese in giro. Che poi col tempo possano risolvere, nel caso dovessero averne, problemi di salute, noi glielo auguriamo con tutto il cuore. Inoltre, auguro loro di sentirsi libere di essere e non di apparire.
Alessandra Federico
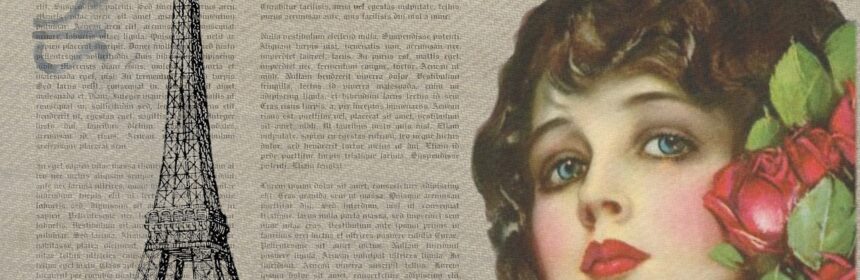



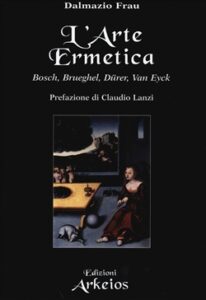 Con un andamento dicotomico lei contrappone Eterno e Contemporaneo: non ravvede possibilità di sincretismo?
Con un andamento dicotomico lei contrappone Eterno e Contemporaneo: non ravvede possibilità di sincretismo?


 Il percorso della protagonista si dipana anche a ritroso nel tempo; si serve di ricordi ingialliti e via via emergenti. La sua personale indagine adopera flashback che compongono un puzzle di notevole suspense. Quale valore attribuisce all’elemento della “memoria” nella sua produzione? Si possono davvero chiudere i conti con il passato?
Il percorso della protagonista si dipana anche a ritroso nel tempo; si serve di ricordi ingialliti e via via emergenti. La sua personale indagine adopera flashback che compongono un puzzle di notevole suspense. Quale valore attribuisce all’elemento della “memoria” nella sua produzione? Si possono davvero chiudere i conti con il passato?
 Fughe intenzionali, amori inammissibili, piccole ossessioni, flirt goffi, mestizie fulminee, inerzia dell’esistenza, desideri latenti, lontananze subìte e cercate, famiglie sguaiate e complesse, ricerca di inediti equilibri e nuove identità. Molteplici e plurimi temi per un romanzo corale. Può motivare la scelta della polifonia?
Fughe intenzionali, amori inammissibili, piccole ossessioni, flirt goffi, mestizie fulminee, inerzia dell’esistenza, desideri latenti, lontananze subìte e cercate, famiglie sguaiate e complesse, ricerca di inediti equilibri e nuove identità. Molteplici e plurimi temi per un romanzo corale. Può motivare la scelta della polifonia?


