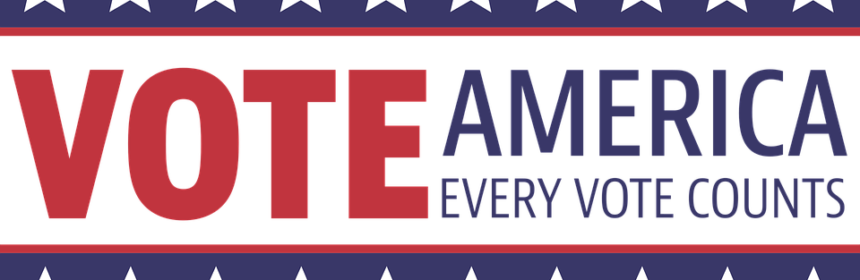Con Alessandro Aresu parliamo di politica ed economia.
l capitalismo politico rappresenta la chiave di lettura principale da lei proposta per accedere al presente. Può definire siffatta categoria?
Il capitalismo politico è l’accoppiamento tra economia e politica all’interno delle potenze, attraverso diversi strumenti. Questi strumenti sono l’uso politico del commercio, della finanza e della tecnologia, la partecipazione statale nelle imprese e più in generale i rapporti tra apparati burocratici e aziende, le sanzioni, le barriere agli investimenti esteri.
Nel mio lavoro, sostengo che questo sistema governi il mondo, perché praticato da Stati Uniti e Cina, seppur in varietà diverse.
Lei descrive minuziosamente l’antagonismo tra diritto ed economia in atto fra Stati Uniti e Cina. Quali sono i termini filosofici di questo scontro?
Le due potenze vedono diversamente il mondo, si pensano diversamente rispetto al mondo, nelle alleanze, nell’influenza internazionale, nell’idea di conquista, nel rapporto tra l’individuo e la comunità. La comune adesione a un sistema capitalistico non cambia queste differenze molto profonde, che pertanto è importante studiare. Ed è sempre cruciale il ruolo dei “traduttori” tra le culture, anche durante i conflitti.
Pechino e Washington vivono un infiammato conflitto di geodiritto: quanto sanzioni, istituzioni internazionali, blocchi agli investimenti esteri influiscono su una guerra ormai tecnologica e giuridica?
Influiscono molto e l’influenza avviene a più livelli. Anzitutto perché le sanzioni degli Stati Uniti non riguardano solo loro stessi, per via della centralità globale di Washington, in particolare nel sistema finanziario. Come cerco di mostrare nel libro, per esempio, l’esclusione di alcune aziende cinesi da parte degli Stati Uniti in alcuni mercati – pensiamo oggi alla discussione sulle telecomunicazioni, un tema presente sulla scena da più tempo riguarda lo spazio, per esempio i satelliti – non coinvolge solo gli Stati Uniti, ma anche gli altri Paesi che hanno rapporti con quelle aziende. Diventa quindi una questione globale.
Nelle grandi operazioni di fusioni internazionali, possono intervenire inoltre le decisioni delle autorità competenti dei vari Paesi. Non solo e non tanto il merito delle loro decisioni, ma anche le loro tempistiche possono essere influenzate da considerazioni geopolitiche. Anche questo rientra nei casi del geodiritto.
L’economia politica al suo primo vagito è stata delineata nei suoi confini da un’affermazione di Adam Smith: “La difesa è molto più importante della ricchezza”. Anche oggi il mercato ha il suo unico limite nella sicurezza nazionale?
Il limite che la sicurezza nazionale impone al mercato è importante perché il concetto di sicurezza nazionale è centrale per la comprensione e per l’articolazione della sovranità. Leggere le trasformazioni della sicurezza nazionale, a mio avviso, è più utile di parlare semplicemente del ruolo dello Stato nell’economia. La sicurezza nazionale ha un forte rilievo per mettere in luce il rapporto tra sicurezza e tecnologia, che orienta e limita il mercato.
La sua ricerca segue tre filoni: la storia dello Stato moderno e dei suoi apparati burocratici; gli ordinamenti giuridici con cui i mercati interagiscono; la storia dello spazio in cui, in passato, è germogliato il capitalismo. Tali direttrici possono convergere?
Sì, è importante evidenziare i rapporti tra queste direttrici e tra questi aspetti, per esempio nella storia e nella continuità dei vari apparati burocratici e nella considerazione storica della progressiva marginalizzazione dello spazio europeo. Chiaramente la ricostruzione che propongo sugli Stati Uniti e la Cina potrebbe essere ampliata anche facendo riferimento ad altre realtà, come per esempio il Giappone, la Russia, la Turchia, e approfondendo meglio i rapporti tra i Paesi europei.
Alessandro Aresu è consigliere scientifico di Limes, direttore scientifico della Scuola di Politiche e consigliere del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale. Si è laureato in filosofia del diritto con Guido Rossi all’Università Vita-Salute del San Raffaele di Milano, dove è stato anche allievo di Enzo Bianchi e Massimo Cacciari. È stato consulente e consigliere di diverse Istituzioni, tra cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Agenzia Spaziale Italiana. Collabora, tra gli altri, con Treccani e L’Espresso. Tra le sue ultime pubblicazioni, L’interesse nazionale. La bussola dell’Italia (con Luca Gori, il Mulino, 2018).
Giuseppina Capone